Testo: Silvia Tebaldi
Copertina: acquarelli di Silvia Tebaldi
Viene al mondo il quattro marzo, alle tre dopo mezzogiorno, in una casa di pescatori alla foce del Po grande.
Suo padre insegna alla scuola di Ca’ Zuliani, con supplenza annuale, e ha preso due stanze in affitto; sua madre ha vent’anni. Il maestro torna da scuola in bicicletta, sotto la pioggia, e la donna ha rotto le acque con anticipo; lui torna fuori a cercare qualcuno, a quell’ora, in quelle solitudini, trova la zia di uno scolaro (lo scialle in testa, il paltò verde scuro), la porta a casa sulla canna della bicicletta ma ormai è uscito il sole ed è già successo tutto, la bambina è nata e la madre ha fatto tutto da sola, anche tagliare il cordone.
La chiameranno Eugenia.
Di quella casa ricorderà per sempre l’estate del 1969, padre e madre e i nonni paterni e la sorella Ginevra di sei anni, la famiglia al completo insomma, per chissà quale motivo via dalla città, sotto un sole che urla, nell’inspiegabile estate del 1969, nella mai spiegata estate del Delta, in quella vecchia casa affittata per due mesi; l’aperto, il vento, la luce salmastra. Lei ha nove anni, i sandali con gli occhi e sa che la sua famiglia sta per esplodere; l’Apollo 11 si è posato sulla luna e i cosmonauti, come li chiama suo nonno Paolo, balzano sul fondo nero dell’unico televisore nel raggio di chilometri, quello del bar sulla provinciale e mai, mai nella sua vita lei si stupirà delle imprese spaziali, perché non c’è nulla di strano, al Delta del Po, se ti senti perduto nello spazio.
Cresce di capelli scuri, magra, e crescere è una città di pianura, orti, il mangiadischi e il mangianastri, entra nell’adolescenza con i jeans Roy Rogers che passano dalla cugina Gloria a lei a Ginevra, con la scuola in Borgo dei Leoni, la bicicletta in cortile e un uomo grande che le tocca il sedere, ma son cose che succedono, dice la zia Luisa e di non mettere la bicicletta in cantina, di non dir niente al maestro, chissà perché.
E poi c’è lo stupore delle lingue, rosa rosae, le frasi che l’alba trasforma in canzoni (l’alba di via Porta d’Amore, di là i baluardi e cieli di cotogne e cenere, Ferrara che entra nell’autunno) e infatti ecco l’autunno del 1974 e lei ha scelto il liceo, i pioppi in fuga da via Ercole d’Este, il dizionario Rocci con il suo nome scritto a penna blu al frontespizio, Eugenia, solo lì e nel registro di scuola perché dal tempo dell’uomo sulla luna, del gesso sul selciato, dei sandali con gli occhi lei è Jenny, Jenny Lupo.

Trovatori, Beowulf, Dante con il commento del Sapegno; troppo sangue ogni mese, De André e i Genesis sono già classici e le ripetizioni ai figli dei vicini e potrebbe essere una vita anche così, infatti si iscrive a lettere con la benedizione di suo padre, il maestro Franco Lupo non più supplente, che la ospita a Padova dove vive con la sua nuova moglie ma niente figli, e lei passa filologia romanza e italiano uno ma poi passa l’Adige, il Po e anche il Reno e al secondo anno si iscrive a Bologna: altri esami, altri portici e invece di tirar tardi al Liviano, tra i fuoricorso tabacconi di Lotta Continua, o alle aule di Maldura, adesso studia in treno e in Porta d’Amore c’è sua madre non più ventenne e Ginevra che entra ed esce da bulimia, anoressia, depressioni e pianti – Ginevra è entrata nell’oltranza, scrive Jenny Lupo in un taccuino verde con la data del maggio 1983, l’oltranza degli anni Ottanta, che ignora il proprio nome.
Poi trova una stanza a Bologna, in via Martinelli, studia le lingue e vive di traduzioni e ripetizioni in zona Emilia Ponente e si laurea con il massimo ma tardi, lavora, i dialetti le inflessioni le cadenze le si attaccano addosso come spighe matte nei campi, e a volte guarda il vuoto dal Pontelungo.

Il biografo, la biografa di una donna resiste a soffermarsi su figli, aborti, amanti e mariti ma un po’ è come se udisse le domande dei parenti, dei vicini di casa, della dubbia comunità dei lettori, una muta insistenza e dunque dirò soltanto che erano gli anni del femminismo e poi della gran sbronza degli anni ’80 e che Jenny non ebbe mai un fidanzato-in-casa, sì invece amanti e anche un marito, cosa questa però finita in fretta; ed ebbe il dono delle lingue, di cui Jenny Lupo conosce il prezzo – il demone di Babele – già dai tempi del mangiadischi e della cantina.
Il tempo passa. Concorsi, collaborazioni e pubblicazioni e traduzioni e una stagione ai lidi di Comacchio in un albergo; porta con sé sua madre, non più ventenne, che cammina sulla spiaggia un’ora al mattino e poi la divora il letto, la stanza verso la pineta, forse anche lei perduta nello spazio. Ora è il 17 novembre 1989, il giorno in cui abbattono il muro di Berlino, e Jenny Lupo torna a Comacchio; è sola, è sfinita, è solo un giorno vuoto e senza perché, con una luce quasi orizzontale e due donne al ponte del Carmine, vestite di nero, che gesticolano senza parole; cade la sera, Jenny torna a Bologna e si chiude in casa, in via Martinelli, per tre settimane esce solo per pranzare con la vicina, pranzano senza parole, attraversa il cortile con un libro, quando finalmente esce di casa via Emilia Ponente è ornata di luminarie natalizie tristissime e lei è pronta, diventa interprete della lingua dei segni.
Qui si affastellano i ricordi, le tracce, i testimoni. Foto ricordo dei capodanni dei sordi delle province di Ferrara e Bologna, di pizze matrimoni e gite ma soprattutto vertenze sindacali, convegni e commercialisti, udienze, piazze con la comunità dei segnanti. Qui imparo che la lingua è in tutto il corpo, annota Jenny Lupo in un taccuino bordeaux del 1995, e tra i parenti di Ferrara e Ginevra ormai grave obesa e sua madre, che hanno sempre più spesso bisogno di lei e certe amiche, c’è chi non si dà pace del suo andare, perché non un impiego fisso e un ruolo e una carriera, lei che sa le lingue e ha capelli grigi che non tinge, mani nude e mai ferme e senza anelli e un matrimonio finito e niente figli. Ma quando le chiedono il perché, lei ride e non risponde e nel taccuino bordeaux scrive la certezza di vivere su una linea di faglia, la depressione di Ginevra e di madre mi aspetta girato l’angolo, ma io attraverso la strada, e di là è la lotta senza quartiere contro il dar di gomito, contro la curiosità laida per il diverso e il pietismo vigliacco, la sordità intesa come malattia, la retorica coperchio della cloaca, o è una rissa invisibile di parole che mi insegue nel tempo, così scrive Jenny Lupo nel 1995 ma forse è così da sempre, dal tempo dei sandali con gli occhi, dell’ingrosso di detersivi in piazzetta Colomba, un labirinto di cartoni che ormai ricordano in pochi, lei sì perché è in quel labirinto – che ancora sogna di notte – che imparò a leggere sui nomi dei fustini, con sua madre poco più che ventenne.

Giunge ora il 2008, la crisi, Facebook, qualcosa che chiamiamo ancora depressione ma invece è il capitalismo, la palingenesi dell’estinzione, la piccola borghesia impoverita, il crollo del lavoro e il pieno orchestrale di malafede e cialtroneria, concerto grosso e capolavoro dell’opera italiana, si stende sulle campagne tra capannoni e lavori interrotti e rovine. Il tempo tra il nevone e il terremoto del 2012 si porta via prima sua madre non più ventenne poi Ginevra sua sorella (nella lingua dei segni, sorella è il gesto di pitturarsi le unghie) e scazzi furiosi squassano il gruppo di segnanti con cui Jenny fa trekking in Appennino. Jenny lavora e assieme entra nel lutto e nella casa di Ferrara non torna quasi più, ma ciò che più le fa male – così racconterà a sua cugina Gloria nel settembre 2012 – è la pietà ficcanaso, poi scrive su un quaderno a righe di terza e copertina nera il linguaggio come un taglio addosso, il linguaggio che non si ferma mai, che non sappiamo come funzioni, da dove venga, che forma inutili spirali di fumo come esorcismi della morte, della follia, che forma verità indecidibili.
Lavora troppo, dorme male, è il lutto, è la terra che trema per mesi tra Ferrara e il nordovest, è la menopausa, è il tardocapitalismo travestito da pecora, da lupo, da medico della peste, da vecchio grasso e unto in doppiopetto, da virus e da delibera consiliare; è la lingua delle brave ragazze sopravvissute alla mutazione, interpreti e traduttrici senza mandato – soldati col grembiale, che resistono anche senza munizioni – e Jenny Lupo sta crollando, ma senza darlo a vedere.

Tutto accade nel torno di tre ore.
È sabato, i sordi sono passati a prenderla con il Transit in via Martinelli, l’idea era di camminare in val di Zena (da principio, lei non voleva andare) ma invece senza dir nulla prendono la san Vitale fin dopo Lugo, Voltana e poi nella nebbia fino ad Anita – Jenny Lupo quasi non se ne accorge, occhi chiusi e sedile posteriore e il berretto calcato, è il tre marzo del 2013 – ed è allora che entrano nello spazio, la nebbia è sparita, luce di marzo, la strada un filo sottile un argine un segno di matita tra il canale e la steppa a sinistra, e a destra il mare interno che pulsa nella luce, la valle grande, la fossa di porto che è acqua feroce, acqua mossa da un vento immateriale come nell’incipit del libro della Genesi, come all’inizio del tempo. E attraversano le valli e nessuno di loro parla, Piero Polon alla guida e nessuno sta segnando e Jenny Lupo ha aperto gli occhi e piange.
Poi al mercato di Comacchio c’è l’anguilla nel mastello, quella del cinema neorealista e non, quella del folklore comacchiese televisivo e letterario e turistico e Jenny sta a braccetto con Ilde Ravagnani e guarda il sole, la bora mandata da Trieste e non c’è nessuna parola astratta (parole come vegano, animalista, antispecista o postumano) mentre Jenny Lupo guarda l’anguilla che si anella e si contorce e forse ricambia lo sguardo nel suo spasimo e Jenny Lupo non dice nessuna parola astratta ma solo questo, con la voce e i segni: sirena del nord, sorella.

Dei giorni che seguono, ben poco si può dire.
Marzo incede con bufere e scrosci, Jenny si è chiusa nella casa vuota di Porta d’Amore – vuota si fa per dire, è un cenotafio di cornici e trucchi, il bailamme, l’accumulo seriale di Ginevra, abiti extralarge, di sua madre non più ventenne, l’oltranza dei sottobicchieri di peltro e dei peluches, riviste, bottiglie, il marasma che toccherà a lei affrontare e guarda i pioppi che tremano sui baluardi, non esce di casa e spegne il telefono ma ecco il campanello, fissato storto sullo stipite fin dai tempi di Franco Lupo suo padre, il campanello che era di ottone o forse di bronzo dell’età del bronzo che suona e inspiegabilmente suona e insiste e infine Jenny apre.
Apre e ora torna in scena Franco Lupo, suo padre non più supplente, già bordighiano e campione regionale categoria pesi medi nel 1955 poi maestro, direttore didattico, forzista della prima ora, poi leghista, vedovo della moglie padovana e infine morto nel sonno il tre marzo, senza farne partecipe nessuno.
Che le lascia, come da testamento presso lo studio notarile Scabbia, in piazzetta Cacciaguida a Ferrara, dicevamo le lascia la casa dei pescatori fuori da Ca’ Zuliani, quella delle doglie in anticipo, quella dello sbarco sulla luna, tre vani e magazzino pagati un cazzo, come precisa Franco Lupo nel testamento (e aggiunge zona fortunosamente ignorata dal recupero turistico del Parco del Delta), pagati un cazzo nel novantacinque senza dirlo a nessuno.
Che le lascia.
Che mi lascia.
Essere all’ora del mondo; essere – annota Eugenia su un quaderno Muji A5, copertina nera, senza data – essere come l’erba.
Ha pulito la casa di Porta d’Amore; ha lasciato la stanza di via Martinelli, che teneva in affitto da allora. Si è tagliata i capelli. Essere come l’erba.
Al biografo, alla biografa di qualcuno – anche di Jenny Lupo con le lingue addosso, Jenny Lupo che traduce tutto, ma forse non proprio tutto quando la trattativa o l’udienza o il gioco si fa duro, Jenny Lupo infuriata col padrone che taglia, con la retorica botola-di-fogna, con la mozione cialtrona in assemblea – insomma a chi prova a scrivere una vita premerebbe di dire anche della morte, del come perché e quando, del raggio in cui si inscrive il primo cerchio; e se non di felicità e infelicità, di parole astratte dentro una vita, dire almeno di fonti consultate, tracce e testimonianze, di come e perché ha in mano quelle carte, questi quaderni e taccuini; ma non per me, non ora questo compito. Ora guarda Jenny Lupo all’ora del mondo, nel poco giorno di novembre sull’ondale della porta, fuori Ca’ Zuliani: ha i capelli grigi arruffati, giacca a vento, gli occhi chiusi nel sole. La tramontana ha spazzato il cielo, la bora mandata da Trieste, la piena di Po è entrata finalmente in mare, acqua nera melmosa in acqua chiara e Jenny Lupo nella luce frontale del tardo autunno, nella prospettiva frontale che fu delle icone bizantine e poi, con tutto il rispetto per le icone bizantine, delle riprese di certi registi, di certi film d’autore di quando Jenny, Jenny e io, eravamo giovani. Guardala, Jenny Lupo nell’ora del mondo, nella luce satura del giorno breve; eccola, non serve nemmeno che guardi da vicino, nemmeno un primo piano perché tutto, tutto è a fuoco.


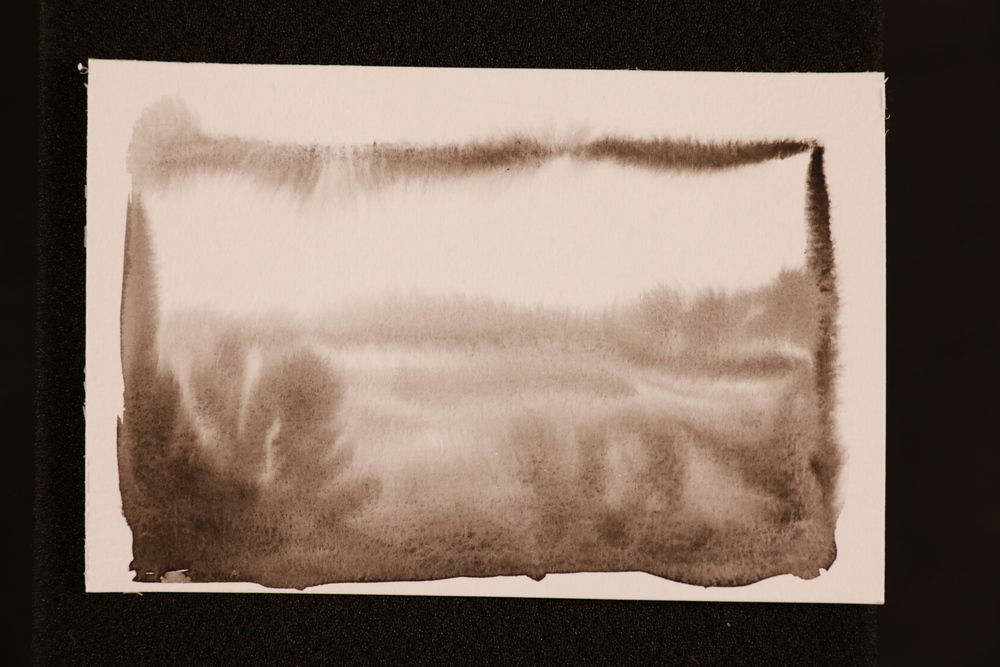
Quante cose che si appiccicano all’anima, come le spighe matte. Malgrado tutto, i coniugi , i figli, gli amanti. Malgrado la polvere che il tempo sedimenta come un oblio consolatorio su vecchi ed antichi dolori. Quel vento di Ca’ Zuliani fa vibrare quelle spighe piantate nella carne e nell’anima. Ma ritrovare quel buio angolo tra i cartoni in fondo al magazzino di via Colomba lenisce un po’ quelle punture che ci hanno fatto diventare così come siamo,
come Jenny Lupo, a volte troppo a fuoco. Cerco di ascoltare, nella mia testa, la voce smorzata di una radio a valvole che culli dolori e memorie profonde.
Complimenti signora Tebaldi.
grazie Silvia
NOTEVOLISSIMO! ADELPHI: BATTI UN COLPO!
Silvia scrive e seguo tutto con la consapevolezza di aver vissuto anche io ogni parola e ogni immagine. Un’altra storia, ti prego.
Mammamia. È bellissimo.
stupendo, una vita. Brava Silvia!