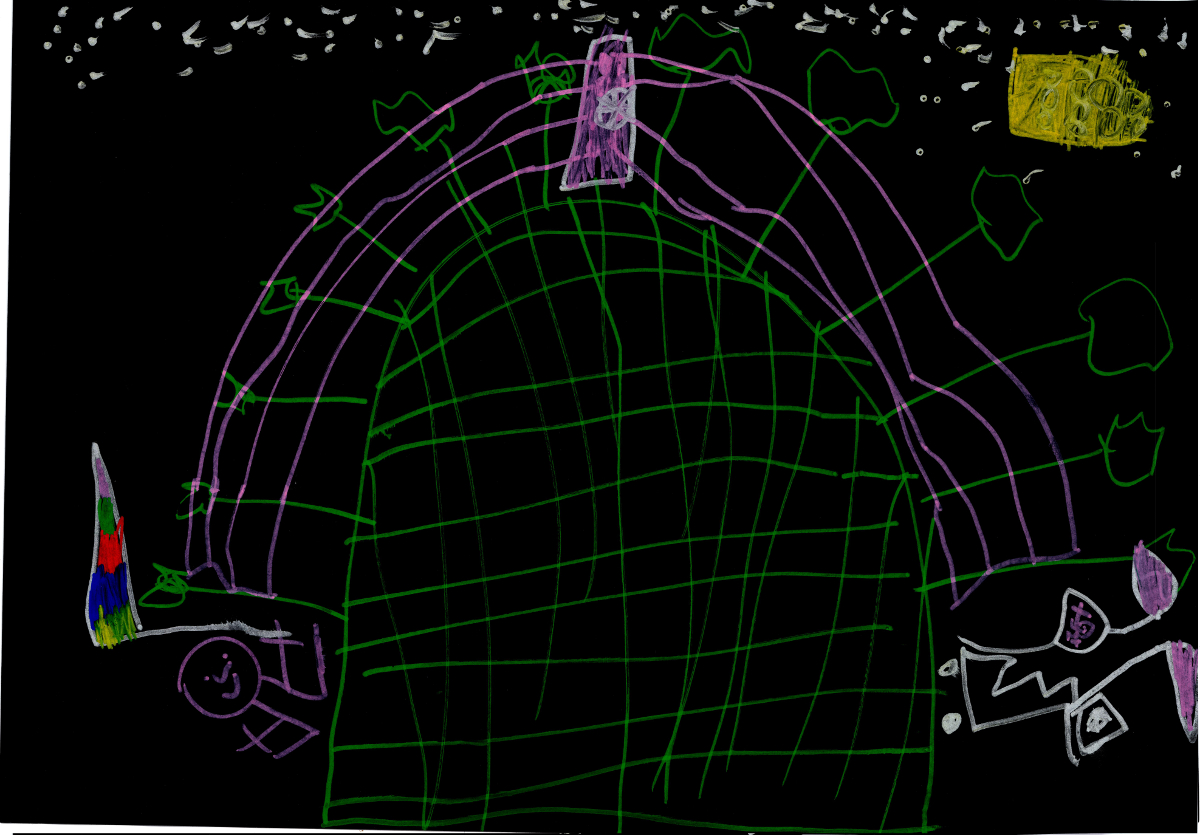di Nicola De Zorzi
Copertina di Pablo Follieri
C’è una giovane donna seduta accanto a me. Mi hanno preso. Mi hanno preso e portato qui e ho paura. Sono tutti bianchi sopra di me, mentre un sole incandescente entra dalla finestra. Vorrei schermarmi gli occhi con la mano, ma mi accorgo che non risponde bene, la mano, come nel sonno, come in una di quelle paralisi in cui cerchi di accendere la luce sul comodino, ma quella non si accende e qualcosa si avvicina, allora tu ti rendi conto che non hai davvero provato ad accendere la luce, l’hai solo immaginato, ma la cosa continua ad avvicinarsi e non sei certo che anche quella sia solo immaginazione, e allora urli o almeno ci provi e
Non credo che mi sveglierò, ora. Non c’è un sogno da cui svegliarmi. Vorrei addormentarmi, invece, e non pensarci più. Ma nutro ancora la speranza che Vivaldini venga a salvarmi. Verrà, giusto? Perché è un compagno e un amico. Vivaldini non verrà perché è morto. Giusto?
Non è mica la prima volta che ho questa sensazione di sonno-paralisi. Mi è familiare da un po’. Familiare? È la parola giusta? Dalla porta socchiusa entra una lama d’ombra nella stanza bianco-incandescente; entra una lama d’ombra come in una stanza buia entrerebbe una lama di luce. Entra ombra, e un ballo come suonato da un’orchestrina, un valzer per 40 elementi suonato da 4 o 5. Un violino, uno o due fiati, una fisarmonica, un piano. Ha quel brusio di carta bruciata tipico dei dischi rovinati.
Questi uomini e donne in bianco mi stanno sopra e sorridono. Fingono gentilezza, quei sorrisi, e pertanto mi terrorizzano ancora di più, rendono più terribile ciò che mi faranno. Riflettono la luce incandescente del sole e vorrei schermarmi con la mano ma non posso e vorrei urlare ma non
Me lo diceva sempre, Vivaldini, di muovermi con cautela.
«Occhio ai rametti, Strauss. Occhio davvero, ché non li vedi ma ti fregano sempre. Credi sia solo muschio e aghi di pino teneri, e lì in mezzo c’è un rametto. E pestare un rametto è come scoppiare un petardo».
Vivaldini veniva da una famiglia di cacciatori, e a cacciare aveva imparato tante cose. Sapeva che un cervo può sentirti respirare a un chilometro, così aveva imparato a respirare più piano di un cervo, e a muoversi più leggero. Vivaldini era il migliore. Io no, io non ero il migliore. C’era chi se la cavava peggio, fra di noi, chi si beccò una pallottola prima ancora di caricare il fucile, ma pure io credo di aver sempre avuto più fortuna che bravura, e se non fosse stato per Vivaldini non sarei durato tanto più a lungo di quelli che son morti il primo giorno, il primo minuto.
«Vedi, Strauss, questo è un buon punto per una tagliola. Qui una martora non la vedrebbe, una tagliola. E se non la vede una martora, non la vede neanche un uomo».
«Non mi chiamare Strauss» dicevo sempre «È un nome da crucco».
E a quel punto Vivaldini rideva e mi spiegava che Strauss era austriaco. E che comunque il nostro nemico non erano i crucchi. Il nostro nemico era quello che combattevamo nei boschi, chiunque fosse, dovunque stesse.
Aveva iniziato a chiamarmi Strauss per via di quel grammofono che avevo portato in base. Avevo portato il grammofono e un paio di dischi lucidi pieni di valzer e polke. Registrati da un complessino in provincia. Suonati con gioia più che con bravura, incisi come veniva. E Vivaldini mi si avvicina e legge la copertina dei dischi e mi dice che da quel giorno io mi chiamerò Strauss, e lì per lì io non protesto perché sono l’ultimo arrivato, ma mi riprometto di ricordargli di non chiarmarmi così, fra qualche giorno, fra qualche sparo.
«E come lo facciamo funzionare, Strauss? Qui non abbiamo elettricità».
Gli altri ridacchiano, orgogliosi del loro buio freddo e duro e stoico.
«Non serve l’elettricità» dico «Basta girare la manovella, così».
E metto il primo disco e giro la manovella e sale quel suono di carta bruciata, e sotto la carta bruciata il violino e i fiati e il piano e la fisarmonica. E i miei compagni, quegli uomini che sono diventati miei compagni in quel momento, smettono di ridere e si fanno un po’ più vicini e ascoltano. È da quel momento che Vivaldini mi è diventato amico. Dice che ho fatto una cosa molto bella, per tutti loro. Dice che non mi dovrei offendere se mi chiama Strauss. Io ci ho messo un po’, ma alla fine ho capito che ha ragione. Sono tutti un po’ più felici con Strauss in mezzo a loro, e per ascoltare meglio Strauss si accalcano.
Bianchi, mi si accalcano sopra in tre o quattro. La giovane donna, piena di furia o tristezza o entrambe, insiste, chiede qualcosa come:
«Ti ricordi di me? Ti ricordi?».
Dev’essere quella cui ho ucciso il marito, o magari il fratello, nei boschi. Ho ucciso molti mariti e molti fratelli, e non me e vergogno. Ho smesso di andarne fiero, ma non me ne vergogno neppure, e se lei è qui per svergognarmi, perde tempo. Ho ucciso molti mariti e fratelli e figli.
Alla fine, però, non riesco a mettere nella mia risposta tutta la sfida che vorrei. Perché ho tanta paura, e sono confuso.
«No» rispondo «No, mi dispiace. Non mi ricordo di te, e neppure di tuo marito o fratello o chiunque sia».
E lei crolla. La furia/tristezza le si espande dagli occhi su tutto il viso, stropicciato come un pezzo di carta, ora, e si siede. Un po’ mi spiace, perché mi schermava dal sole. Chiudo gli occhi.
Stiamo passeggiando in quel parchetto sotto la chiesa, sotto la strada principale ancora così poco trafficata. Passeggiamo per quella che potrebbe essere l’ultima volta per un po’. No: per quella che sarà certamente l’ultima volta per un po’, e che potrebbe essere l’ultima e basta. A pochi chilometri dal paese, nei boschi, suonano gli spari. È strano, come sembrino lontani quando in realtà tutti noi, in paese, siamo potenziali facili bersagli. Rifletto che è come quand’ero bambino: casa mia era vicina al bosco, ma non la più vicina. Ce n’erano altre due più vicine al bosco, abitate da famiglie di allevatori e taglialegna, grossi e burberi. Le loro case erano l’avamposto difensivo del paese da qualunque orrenda creatura potesse abitare i boschi. Così anch’io ero al sicuro. Così ora ero al sicuro perché gli spari vicini/lontani li scoppiavano e se li beccavano uomini come me, che però non erano me, erano lì. E io questo non potevo più sopportarlo. Non sono mai stato coraggioso, ma non potevo sopportarlo.
«Se te ne vai» mi dice Camilla «Prima mi sposi. Così poi devi tornare».
Io non avevo intenzione di chiederglielo. Perché avevo paura di non tornare. Ma lei me l’ha chiesto così, lei l’ha chiesto a me, e ho detto di sì.
La donna triste-furiosa, accasciata sulla sua sedia, piange:
«Ma come puoi non ricordare? Ma come?»
E uno degli uomini bianchi cerca di tranquillizzarla.
«È anche colpa delle medicine. Non faccia così».
Anche? Che mi abbiano drogato è abbastanza chiaro, ma cos’altro mi hanno fatto? Non ricordo come sono arrivato qui, sarò stato ferito. Alzo piano la testa. Il mio piede sinistro non c’è. Sul lenzuolo, si estende dalla caviglia una chiazza di sangue grumoso che potrebbe anche essere la sagoma appiattita del mio piede. Urlo, urlo per davvero, e loro si allarmano. Mi iniettano qualcosa.
Da piccolino avevo l’abitudine di calcolare i secondi che mi spettavano nella vita. Che ce ne fossero 60 al minuto era risaputo, che fossero 3.600 in un’ora era abbastanza facile. Per un giorno, bisognava moltiplicare 3.600×24, che fa… oddio, me lo ricordavo sempre da bambino, 3.600×24, 3.000 x 20 che fa 60.000, poi 600 x 20 che fa 1200, ovvero 61.200, poi 3.000 x4 che fa 12.000, sommati a… quant’era?
Il mio piede è lì, al suo posto. Era un sogno, un’allucinazione, quella cosa che mi hanno dato che, a detta loro, è la ragione per cui non ricordo la donna a cui ho ucciso il marito/fratello. Il mio piede c’è e posso pure muoverlo. Chiudo di nuovo gli occhi, un po’ più sereno.
«Te l’avevo detto» bisbiglia Vivaldini «che se non le vede una martora, non le vede neanche un uomo».
«Ed è per questo che dovresti avvisare di dove le metti, cazzo» ringhio a mezzi denti. Faccio il duro, ma ho paura. Quando la tagliola è scattata attorno alla mia caviglia, non ho sentito solo il morso sulla carne, la carne tagliata e trafitta con un suono di puntaspilli: ho sentito il toc della lama sulle ossa, un chiodo piantato in un albero. Ho creduto che la tagliola fosse l’unica cosa a tenere il mio piede attaccato alla gamba.
«Non ho mancato di avvisare nessuno» ribatte Vivaldini «Sarà che non eri attento, Strauss? Sarà che eri impegnato ad allietarci con un valzer mentre davo la notizia?»
E poi si mette a fischettare piano piano Sangue Viennese mentre apre la trappola, e io mi concentro sul suo bel fischiettio accostato al mio orecchio, non sulla lama, su questa brezza musicale di forma conica ma ti prego non sulla lama che si stacca dall’osso come se volesse portarselo dietro, dalla carne viva con quel rumore di straccio bagnato strappato.
A volte azionavo il grammofono nel silenzio più denso delle notti estive. Volavano molte lucciole fra pini e larici, e l’aria sapeva di acqua e resina. A volte lo azionavo quando non potevo combattere (fui ferito due volte dal nemico e una dalla tagliola) e cercavo di coprire il rumore degli spari con i valzer dell’orchestrina. Una volta cullai un compagno morente, che tenne il tempo con l’indice ondeggiante e un sorriso idiota che gli rimase stampato sul viso anche quando il suo dito si fermò e quindi mi fermai io, come se il moribondo fosse stato il mio direttore d’orchestra.
Non riesco a muovermi su questa branda maledetta. In mezzo a tutto questo bianco, qualcosa sa di sporco. C’è odore di urina. Dio, dimmi che non è la mia. Non riesco a muovere le braccia. È come se non ricordassi come muovere le braccia. Dopo avermi drogato, devono avermi pure legato. Non riesco neppure a sollevare il collo, adesso, per vedere se il mio piede è rimasto lì dopo essere sparito ed essere tornato di nuovo.
Sono calmo. Sono costretto a esserlo, non posso fare altro. E calmandomi, mi rendo conto di quanto, temendo per la mia vita e la mia incolumità in quest’inferno candido, ho pensato così poco a Camilla. L’ho evocata in un ricordo passato, ma non in un’eventualità futura. Non ho ancora pensato a quanto mi spiacerà non vederla più, dato che di certo non uscirò mai da qui. Non ho ancora pensato alla vita non ancora realizzata e già perduta. Non l’ho fatto perché fa male.
Chiudo gli occhi, stanco e triste. Drizzo le orecchie, però. So che la porta si sta aprendo. Sono di nuovo circondato dalle sagome bianche. È tornata la giovane donna. Si fa largo fra tutti e mi strattona. Ordina: «Ricorda! Ricorda, maledizione, ricorda, cazzo!»
E mi fa paura più di tutti, più paura di questo bianco innaturale e degli uomini che attendono il momento giusto per potermi torturare. Mi fa paura perché la donna è Camilla. Urlo, urlo finché la mia gola non sa di ferro. E ancora, mi drogano.
3.600×24 fa 86.400. Bene. 80.6… no, no, 86.400. 86.400, ricordatelo bene. Perché adesso arriva il difficile. 86.400 x 365. Allora, 80.000 x 3 fa 240.000, quindi 240.000 x 100 fa 24.000.000… poi… oddio. Poi? Lo sapevo, giuro che lo sapevo. Non ricordo.
La donna non è Camilla, ovviamente. Le somiglia, questo sì, ma non è lei. Zigomi più duri, sopracciglia più dritte, occhi verdi. Quelli di Camilla sono nocciola, quasi senza sfumature. Ma ridotto come sono, incapace di qualunque lucidità, sono andato nel panico.
«È la terza dose in un giorno. Avanti di questo passo, ci crepa prima che possiamo…»
Prima che possiate fare qualunque cosa vogliate farmi, crepare sarebbe meglio. Magari. Dio, magari. Ed eccoli che tornano.
«Capisco come si sente, ma lo lasci tranquillo» sento che uno di loro bisbiglia alla giovane donna «Cerchi di essere amichevole. Paziente. Sfoghi come quello di prima sono dannosi al nostro scopo».
E la giovane donna sorride, ma vedo la malignità dietro il sorriso, tirato a maschera.
Mi circondano di nuovo e già mi sento soffocare.
«Guardi cosa le abbiamo portato» fa uno «Credo possa farle piacere».
Mi rendo conto che da dietro la porta da cui trapelano ombra e musica, la musica si fa più forte. Un altro uomo bianco entra spingendo un carrello. Sul carrello c’è il mio grammofono. Sembra più vecchio di decenni rispetto a… Dio, da come l’han trattato pare l’abbiano dato ai cani. Pare l’abbiano ripescato dal nostro avamposto. Dalle rovine crivellate, dai corpi dilaniati. Urlo di nuovo e non so cosa dico. Senza che le senta, le mie mani si muovono, la schiena si solleva. Urlano anche loro. Spunta una nuova siringa.
Forse è quello che voglio. La quiete della siringa, che mi insidia mentre mani intangibili mi tengono fermo e la giovane donna piange. L’ago mi sfiora la pelle, si immette in un poro. Poi, la porta si spalanca.
Urlo di nuovo, ma di gioia stavolta, mentre Vivaldini irrompe nella stanza. Vivaldini verde e marrone, color fango e muschio, profana il candore di questo inferno con violenza, con gioia. La sua mira infallibile è sprecata per bersagli così vicini. Quando li abbatte, perfino il loro sangue è bianco, le loro interiora che schizzano a tocchi, schiantandosi sui muri e sparendovi contro. Solo la giovane donna è risparmiata. Rannicchiata ai piedi della brandina, riceve uno sguardo di pietà dal mio amico, che mi slega polsi e caviglie e si avvolge le spalle con un mio braccio.
«Strauss» dice allegro e concentrato «Sei capitato su una tagliola peggiore delle mie».
Vorrei ridere, ma tutto quell’urlare mi ha
Ci sbarrano la strada, ma Vivaldini è implacabile, invincibile. Il fucile spara a ripetizione, e quando finisce le munizioni, Vivaldini tira fuori dal giubbotto una tagliola, che brandisce per la catena e mulina in aria, fischioragliando, mutilando e smembrando.
Corriamo fra i corridoi bianchi, sempre meno bianchi, invasi dalla luce ororamata dei boschi. Quando i miei piedi calpestano il terreno tutto aghi umidi di pino e muschio, mi guardo alle spalle, e vedo che il luogo in cui ero rinchiuso non era altro che l’avamposto.
«Bastardi» dico «Ci hanno occupati dopo averci…»
Faccio per girarmi verso Vivaldini. Calpesto un rametto, e il mio amico non è più lì. Sono al limitare del bosco, da cui vedo le ultime case del paese. Mi accolgono allevatori e taglialegna, sempre grossi e burberi, ma ormai io sono più alto di loro.
«Ci hai protetti come noi abbiamo protetto te quand’eri piccolo» si complimentano «Bravo, ragazzo, bravo bocia».
Vado a farmi stringere la mano, ma inciampo in un rametto. Allora compare Camilla, che mi prende per il braccio e mi porta all’altare.
«La sposa può baciare lo sposo».
«Non l’avevamo già fatto, questo?»
«Possiamo farlo tutte le volte che vogliamo».
L’orchestrina suona una versione scarna e vivace del Bel Danubio Blu, e io e Camilla balliamo.
«Strauss» dice «Cos’era quella storia dei secondi?»
«Volevo sapere quanti ce ne sono per un uomo. Uno che viva, diciamo, 80 anni».
«Una bella età! E quanti sarebbero?»
«2.522,880.000» rispondo. E rido, perché me lo ricordo! Come avevo fatto a dimenticarlo? Avevo tentato questo calcolo da bambino, decine di volte, fino al risultato definitivo, esatto e indiscutibile. Perché me l’ero dimenticato? Avevo smesso di ripeterlo fra me e me arrivato ai 40 anni, perché 1.261.440.000 secondi non c’erano già più. Anche se adesso non ho 40 anni. Mi sono sposato a 22; Camilla ha anno in più di me.
«Sono proprio tanti. Tanti passi di valzer, eh, Strauss?»
Finiamo il ballo, quindi Camilla mi prende per mano e passeggiamo nel parchetto sotto la chiesa.
«È qui che mi hai chiesto di sposarti» mormoro. Poi, impreco mentre sotto il mio piede esplode un rametto.
«Cosa?» ride la giovane donna.
«Volevo dire. È qui che tua madre mi ha chiesto di sposarla».
Mia figlia ride serena e paziente. Somiglia molto a sua madre, ma ha gli zigomi più duri, le sopracciglia più dritte e gli occhi verdi.
«Quanti secondi restano, papà?»
«Io… oddio, fammi… lasciami…» Tento di contare i miliardi, forse oramai solo milioni o migliaia, sulle dita «Non me lo ricordo».
Guardo la giovane donna e la sua maschera d’odio che forse non è odio, solo tristezza.
«Chi è lei? Non ce l’abbia con me, la prego. Tutti abbiamo dovuto fare cose che… mi spiace di averle recato tanto dolore. La guerra è…»
Mi fa male il piede. Temo di vederlo nuovamente mancante, monco, ma è lì, intero e vecchio. Venato di blu, rugoso. Sulla caviglia antica e nodosa c’è la cicatrice che mi accompagna dal giorno in cui Vivaldini mi ha liberato dalla tagliola; si è avvolto le spalle col mio braccio e ha tentato di portarmi all’avamposto. Dovevamo far piano, il nemico era a pochi passi. Poi ho calpestato un rametto.
La giovane donna continua a sedere accanto a me. Credevo volesse torturarmi, credevo volesse assistere alla torture degli uomini bianchi, ma ho come il sospetto che gli uomini bianchi intendano torturarmi con lei. Non so se mi spiego. Non so se capisco quel che sto dicendo pensando ricordando.
Com’era quella storia dei secondi?
C’è una giovane donna seduta accanto a me.
Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?