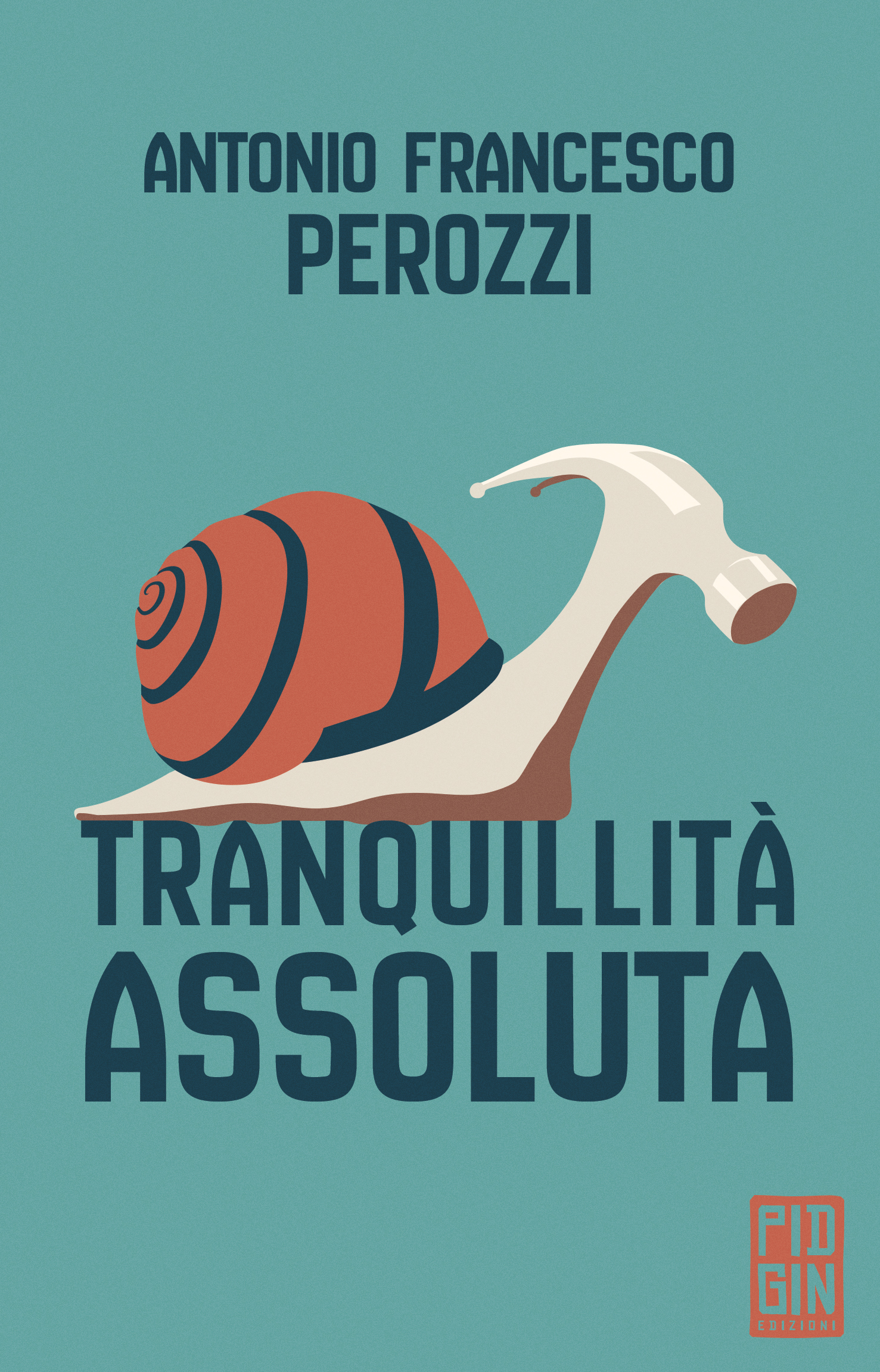di Giovanni Peparello
copertina di Pidgin Edizioni
“Dalle nostre parti quelli strani li ammazzano”. Inizia così il primo racconto di Tranquillità assoluta (Pidgin) di Antonio Francesco Perozzi, e in effetti per tutto il libro non c’è una sola cosa strana e nessun avvenimento inconsueto. Tutto è normale – normalizzato nella quotidianità dei personaggi e del contesto. Tutto va come deve andare, tutto scorre liscio, anche quando sotto la cupola di vetro di un centro commerciale un gigantesco insetto divora la testa di un passante. “Nessuno reagisce. Tutto accade in un ghiaccio, come fosse programmato da tempo”. Da quel momento gli altri nove racconti si manifestano come incubi: nelle periferie e nei sobborghi continuano ad accadere cose assurde, tra gigantesche palle di sterco che vengono ingurgitate alla festa del patrono, tubi di amianto che gettano in mare liquidi verdastri, grandi sacche di sangue nascoste sul retro dei locali da cui succhiare per sballarsi. Eppure tutto è normale, tutto è normalizzato, niente avviene al di fuori della routine.
I grumi che non passano dallo scarico
Chi è strano muore, perché chi è strano viene ammazzato: Tranquillità assoluta raccoglie racconti che parlano di un mondo attuale, misero e materiale, con una vena di surrealtà che pulsa appena sotto la superficie e che sempre minaccia di rompersi e dilagare. Sotto questo costante pericolo di aneurisma, i mondi che inventa Perozzi sono mondi normali, perché l’aspetto sovrannaturale non arriva a fulminare la normalità ma a esaltarla. Questo labirinto è estremamente dozzinale: si parla di soldi, sempre di soldi, di lavori che pagano poco, di furti pensati per alzare qualche millino, di prese in carico scolastiche giusto per levarsi da casa, di relazioni sfilacciate e disfunzionali, sullo sfondo di una provincia stagnante – una provincia infernale che domina il panorama anche quando i personaggi vengono risucchiati dalla città, rimanendo a sguazzare nell’emivita dei pendolari come grumi di capelli nello scarico della doccia. Questa provincia – che è provincia essenziale, che si materializza da Nord a Sud, passando dal Centro, e che non esula mai dal contesto – sembra allora composta da tutto quello che è stato rigettato dallo sgorgante, da tutto quello che non è passato dal tubo.
Involontari Celibi Involontari
I protagonisti e i narratori di Tranquillità assoluta sono tutti maschi agli albori dell’età adulta, con i piedi ai due lati della soglia. Tra chi accetta e chi rifiuta la sconfitta incombente, tutti rimangono sospesi tra le responsabilità e il rifiuto, tra il furto e il lavoro sottopagato – oppure si lasciano andare al nulla, trascinati dagli impulsi irresistibili di una sessualità che è di volta in volta repressa, incestuosa o masturbatoria. Le relazioni con le donne sono votate alla catastrofe, in un rapporto di insofferenza o di aperto odio che non sfocia mai nella violenza – semmai nell’angoscia dell’irraggiungibilità. I maschi di Perozzi soffrono un senso di inferiorità irrisolvibile nei confronti del genere femminile, un femminile che comunque rimane molto reale, molto presente, tutt’altro che etereo, come se fosse l’unico spiraglio di luce del labirinto. Le donne sono forti ma distanti, imperscrutabili, capaci di calcoli che i protagonisti “non riescono a dedurre”, evocatrici di desideri frustranti.
Moriremo in un supermercato
Davanti a ogni stanza di questo labirinto sono appese le insegne che appestano le nostre giornate. In Tranquillità assoluta non ci sono astrazioni o utopie: queste storie da incubo non si svolgono in un supermercato generico, ma in una Pam o in un Carrefour, tra gli H&M e i Bershka. I personaggi parlano di iPhone, Pringles, Peroni. Ogni marca evoca un ruolo e un valore che i lettori già conoscono, che Perozzi non inventa e non inserisce casualmente nel mondo, ma che mette a disposizione con tutto il palinsesto culturale che comporta. Intimamente, fin dalle nostre infanzie perse nelle mattine delle “pubblicità di Media Shopping”, sappiamo bene cosa significa se un personaggio per cena mangia i Sofficini, se va a fare la spesa e compra i gelati Dolciando o lo shampoo Felce Azzurra. In questo inferno consumistico, le sottomarche sono il girone più basso, il segno di una sconfitta irrimediabile. Siamo nati in un supermercato, moriremo in un supermercato, e è impossibile distogliere lo sguardo dagli scaffali, anche se intorno a noi la gente cambia la pelle come i serpenti.
L’Assurdo nella chiacchiera da bar
L’esposizione a questo mondo consumistico normalizza gli eventi più grotteschi delle storie, così come l’esposizione a TikTok normalizza la frequenza degli impulsi sessuali in erezioni pavloviane. Forse è proprio questa la cifra stilistica di Perozzi: la normalizzazione. Il mondo è sempre identico a sé, nemmeno l’Assurdo riesce a farci alzare la testa. Questa normalizzazione dell’Assurdo è sostenuta anche dall’uso di una lingua che tende al parlato e a volte al dialetto, piana e ipotattica, con riferimenti culturali quasi totalmente mainstream, esclusi i vezzi di alcuni protagonisti. Non c’è niente di grandioso in ciò che leggiamo, ogni personaggio sembra rappresentare la media dell’umanità, seduto al bar un giorno qualunque a raccontare della sua misera vita, mentre alla festa del patrono i nostri compaesani si nutrono del santo sterco.
E tu, come ti spogli dell’esuvia?
Questa arteria pulsante di surrealtà è riassorbita nella coerenza interna delle storie essenzialmente in due modi: o con il ricorso a un finale che ribalta le prospettive, o tramite la presentazione di fatti incontrovertibili dal principio della storia. Come quando Gregor Samsa si risvegliava tramutato in un immondo insetto, e nessuno si premurava di spiegarci il perché, e tutti lo accettavano come se fosse la cosa più normale del mondo, i protagonisti di Mal di testa hanno uno sciame di lucciole che abita il loro cervello e li illumina pericolosamente mentre rubano in un magazzino. Perozzi non costruisce metafore lampanti e non le rende nemmeno il punto di partenza della storia, né il fulcro. Queste assurdità sono semplici dati di realtà che i personaggi condividono. L’Assurdo è sempre inserito all’interno di un preciso contesto socio-economico: così in La gloria di Dio i bagnanti al mare in Calabria si tengono ben lontani dai gerr’, una sorta di etnia non meglio specificata, un po’ pelosa, strana, capace di camminare sull’acqua, umana ma non troppo. In questa normalizzazione dell’assurdo, i personaggi di Perozzi si perdono in delicatezze comuni, come quando uno di loro si perde nell’immaginazione del sapore di una salsiccetta sott’olio: “Percepisco la lingua immersa nella saliva, una repressione alla bocca dello stomaco e un senso di vuoto alla laringe, un saporino aspro alla fine del palato”. Anche quando viene descritta minuziosamente la muta della pelle di un essere umano, la descrizione deriva dalla rilevanza sociale del gesto e non dalla sua assurdità: “una leggera torsione le permette di sfilare la testa dalla membrana, lasciare che la pelle morta si scolli da quella nuova gradualmente, ma precisa, con piccoli filamenti biancastri che la seguono fino all’ultimo istante, poi si spezzano e vengano riassorbiti di scatto dalla seconda faccia. Guardo il suo viso precedente pendolarle sul petto, gli occhi ora color rame semitrasparente. Lei ha un modo molto ordinato di disfarsi delle esuvie”.
Se gli incubi di Mariana Enríquez durassero fin dalla nostra infanzia
Perozzi impiega sempre meno parole possibili per descrivere la realtà, e lo fa in funzione della storia e della coerenza interna. I racconti di Tranquillità assoluta hanno la stessa grana degli incubi: una cosa semplicemente è, al lettore conviene accettarla, mentre l’Assurdo appare sempre in modo così essenziale, improvviso e normalizzato che comincia ad apparire in agguato dietro ogni pagina, deturpando la realtà anche in contumacia: la mera possibilità dell’Assurdo – il solo fatto che qualcosa di strano possa avvenire da un momento all’altro, che la struttura molecolare del mondo possa cambiare senza preavviso – ci dà la sensazione di vivere all’interno di un mondo fuori posto. La bravura di Perozzi sta nel far risultare questo mondo credibile e coerente. Questa inquietudine e questa immersione nella normalità, nelle miserabili necessità di ogni giorno, fa pensare al modo di rappresentare il mondo che ha Mariana Enríquez. C’è però una differenza essenziale: Enríquez presenta le assurdità e i misteri come eventi che ribaltano la vita delle protagoniste, che costringono i personaggi a ridisegnare la propria realtà quotidiana intorno all’impossibile, tentando di negarlo o di riassorbirlo; molti dei protagonisti di Tranquillità assoluta invece vivono da sempre dentro un mondo grottesco con cui sono venuti a patti da tempo. Anzi, per loro questa è a tutti gli effetti la normalità. Per loro, squarciarsi la pelle al supermercato non è diverso dal comprare i detersivi in offerta.
Scrivere è come giocare e Perozzi è bravo a barare
Così come i racconti di Enríquez descrivono situazioni quotidiane e improvvise, che si concludono prima di arrivare a una conclusione canonica, allo stesso modo i racconti di Perozzi sono privi di centro, e rompono lo schema a cui la letteratura di consumo ci ha abituati. Perozzi sceglie di giocare un altro gioco, anche se sa bene come si racconta una storia: riesce a farlo benissimo fin dal primo racconto, in cui il protagonista racconta il trauma dell’uccisione di un suo collega, Zanna. Un’aria di morte permea tutta la vicenda, e ogni volta che si parla di “ciò che è successo a Zanna” sembra che questo avvenimento perennemente evocato debba diventare il perno entro cui gira il racconto, con un’annunciata rivelazione centrale e nitida. E invece niente, la descrizione arriva e scompare nel buio, senza nessuna chiarificazione, come tutte le cose di cui è impossibile parlare: “un proiettile bucherà il cervello di Zanna”. Tutto qui. Il nitore rimane al di là della cerniera tra noi e il libro. Al di là di questa cerniera sentiamo i personaggi parlarne, ma sono solo sprazzi di conversazione, una porzione ridotta di quanto nella storia venga effettivamente rivelato. Questo piccolo accorgimento rompe il sistema della scrittura e lo fa proprio per lasciare una sensazione di vuoto dove ci saremmo aspettati catarsi e rivelazione. Così quel momento passa, il trauma rimane indigerito, la vita prosegue grigia e ripetitiva sull’autobus tra i monconi di cemento armato. Molti dei libri contemporanei che ho letto mi sono sembrati un gioco a cui gli autori hanno scelto di giocare seguendo le regole stabilite da qualcun altro. Regole fisse, scritte sui muri dei bagni e sulle lavagne di ogni scuola di scrittura, oppure incise nel nostro DNA, marchiate sulle retine dopo duecento ore di serie tv. Perozzi conosce talmente a fondo questo gioco da riuscire a decidere quando seguire le regole, barando con maestria. Barando bene e con coerenza, Perozzi di conseguenza riesce a inventare regole nuove ogni volta che ne ha bisogno. Anche i finali, improvvisi e concisi, più che rivelare aggiungono mistero, allargando l’oscurità oltre le ultime righe. E forse è proprio questa rottura minima nel tessuto della narrazione a turbare maggiormente. Non siamo perduti in questo labirinto: abbiamo trovato la strada e la porta, la via è dritta, c’è aria e c’è luce. Però qualcuno ha nascosto la chiave. Era lì sul tavolo, fino a un momento fa. Poco male: questa sarà la nostra nuova casa. E tutto quello che rimane all’interno sarà la normalità.
Ti è piaciuto questa recensione? La copertina? La redazione? Tutte e tre?