di Romina Arena
copertina di Daria Pesce
Il legame sociologico della letteratura con la realtà
Il 1600 segna un cambiamento nel modo di intendere la letteratura. Le conoscenze si specializzano, i saperi si fanno più specifici e la letteratura cambia collocazione. Da materia erudita si trasforma in elemento di divertimento e intrattenimento. Poco male, pare, perché questo apparente abbassamento di livello ne cambia la fisionomia e anche la capacità di diffusione. Letteratura diventa tutto ciò che non è scientifico o tecnico e, con l’invenzione della stampa e un sistema di distribuzione e scambio sostenuto dalla nascente industria del libro, tutto ciò che riguarda narrazione pura subisce anche un salto sociale di classe. Le lettere, che prima erano appannaggio esclusivo del clero e dell’aristocrazia, grazie a una maggiore diffusione dei testi, alla semplificazione della loro lettura, all’abbassamento dei prezzi e alle pionieristiche edizioni economiche, si aprono a una fascia privilegiata di borghesia illuminata.
Quando alle soglie del 1800 il libro diventa un vero e proprio prodotto commerciale la letteratura così come la intendiamo oggi fa un ulteriore passo avanti, probabilmente definitivo nel definirne la fisionomia e anche una nuova collocazione nella sua dimensione sociale. In quel periodo il suo bacino di riferimento si allarga, l’abbassamento dei prezzi permette anche al popolo minuto di accedere alla narrativa di genere, l’orientamento stesso delle storie che si leggono fanno intendere che qualcosa sta cambiando, che la letteratura non è più un semplice diversivo; che sta acquisendo uno status nuovo. È sempre più difficile, a questo punto, considerarla un elemento separato dall’ambiente sociale e dalla rete di relazioni che vi si sviluppano all’interno. Non è più possibile considerare la letteratura un semplice intrattenimento o un disimpegno.
Venti di cambiamento soffiano sulla narrativa che non ignora i contesti nei quali è immersa, anzi, li narra, se ne fa portavoce, se ne fa portatrice. I cambiamenti sociali, le nuove idee politiche e di progresso, le vicende storiche entrano perentoriamente dentro le narrazioni, nei romanzi di genere, nei feuilleton. Non c’è soluzione di continuità tra la letteratura e il suo tempo. La letteratura parla del suo tempo e il tempo offre materiale al quale la letteratura attinge per crearsi.
La prima ad accorgersene e a riflettere in maniera organica e approfondita sul legame tra la letteratura e la società è Mme. de Staël nel saggio Della letteratura considerata nei suoi rapporti con le istituzioni sociali. Nell’introduzione de Staël dichiara subito che le sue intenzioni sono di: “esaminare qual’è l’influenza della religione, dei costumi e delle leggi sulla letteratura, e qual’è l’influenza della letteratura sulla religione, i costumi e le leggi”. La sua riflessione è dirompente, figlia dell’epoca, certo, e mostra un volto inedito della letteratura, la strappa a una dimensione alta e inavvicinabile per abbassarla a un livello che sia anche alla portata della gente comune. Soprattutto, de Staël non dissocia la letteratura da nessun aspetto della sfera sociale, politica, economica, spirituale, storica, privata e afferma che la sua dinamicità dipende proprio dall’aderenza alla realtà. La letteratura è in sincronia coi cambiamenti sociali e politici e per questa ragione va letta e analizzata in relazione all’ambiente nel quale si situa. Niente più biblioteche polverose custodite da un diabolico Malachia, dunque, ma uno spazio aperto nel quale la letteratura galoppa trasversale alle classi e agli ambienti sociali, alle tematiche e ai tempi.
La riflessione di de Staël è uno spartiacque, una specie di punto di non ritorno. La letteratura si spinge oltre il semplice intrattenimento e la narrazione a scopo ludico o d’evasione. È figlia del tempo che vive e in cui viene prodotta e per capire meglio la sua metamorfosi coinvolge le scienze sociali e sociologiche, vale a dire le discipline che consentono di interpretare gli elementi storici e sociali che caratterizzano una narrazione dal punto di vista dello stile, ma anche la storia narrata dal punto di vista dei costumi e degli eventi. Non scollandosi dall’epoca in cui vive, sapendo guardare sia al passato che al presente e offrendo possibili letture del futuro, la letteratura conferma che il legame che la unisce alla società supera l’idea che essa sia solo un puro esercizio di finzione. Di più, con il suo diventare globale e onnicomprensiva apre a uno scenario mai conosciuto fino ad allora: tutto è letteratura.
La società, coi suoi eventi, le molteplici composizioni, pesa sulla letteratura così come un dato momento storico influenza – nel linguaggio, nella contestualizzazione ambientale e simbolica della narrazione – l’opera di scrittrici e scrittori. C’è un ancoraggio così forte alla realtà – e una visione strettamente marxista della letteratura – per cui un libro non è più una variabile indipendente lasciata alla libera fluttuazione della fantasia. Un libro – e il suo contenuto – acquisisce una sorta di responsabilità di rappresentazione nei confronti della vita materiale tale che non esiste una disconnessione tra un dentro (letteratura) e un fuori (realtà) che giustifichi la tesi della letteratura come esclusivo terreno del fantastico e dell’utopico. Tra il dentro della letteratura e il fuori della realtà esiste una relazione osmotica, di interscambio continuo, vivace e vitale.
La letteratura è realtà. La realtà è politica. La letteratura è politica.
La letteratura è una riproduzione della realtà. Non è possibile collocarla fuori di essa perché ne replica i paradigmi e il tessuto delle relazioni. Sono per questo perfettamente sovrapponibili ed è per un legame così vincolante che non può esserci letteratura fuori dalla realtà né una realtà che possa sfuggire alla letteratura, anche quando si tratta di fantasy, di distopia, di ucronia. La realtà è sempre il punto di partenza della letteratura perché la letteratura è un fatto umano e un atto umano, racconta storie di persone nella storia, incastona vite negli eventi storici e di cronaca, mette in luce le storie piccole delle vite piccole e storie grandi delle vite esposte. Soprattutto, nella letteratura le persone hanno la possibilità di ritrovarsi e di riconoscersi. Per la sua inclusività, chiunque può trovare in essa un luogo da chiamare casa, una trama con la quale rappresentare il proprio personale vissuto. Non esiste una letteratura che non sia alla portata delle persone, non esiste una letteratura inarrivabile. A dispetto delle considerazioni intellettuali – e borghesi – che vorrebbero collocarla in una dimensione accessibile solo a una élite, la letteratura appartiene a chiunque, in senso letterale.
Appartiene a chi sa leggere, appartiene a chi non sa leggere e appartiene in maniera tutta speciale alle persone detenute o alle persone che non godono del privilegio economico, sociale e culturale di accedere all’istruzione, alla conoscenza, alla cultura. La letteratura sta diventando un bene di lusso, è vero, ma la chiave economica non è l’unica possibilità per accedervi. Sul piano pratico esistono presidi di forma e natura diverse in cui la letteratura è gratuitamente fruibile; sul piano simbolico e metaforico, alla letteratura si può accedere riconoscendo una storia dentro ogni narrazione cui si è data disponibilità di ascolto perché la letteratura è ovunque ci sia una storia da raccontare e una persona disposta ad ascoltare. Poi, il resto, è una faccenda alchemica che ha a che fare col mistero dell’incontro. Chi si avvicina alla letteratura sente una lingua che è familiare, prende gli elementi più simili alla propria esperienza di vita, in qualche modo fa proprie le storie che legge. Del resto, la letteratura non promette alcuna salvezza e non custodisce alcun significato ultimo sulla vita, il destino, l’universo. Inutile pensarla come una depositaria di verità e, soprattutto, inutile pensarla come una depositaria di verità riservata a poche persone. Avvicinarsi alla letteratura è un atto libero, fatto nella libertà, con la consapevolezza di assumere una posizione schierata nei confronti del mondo e degli esseri umani. La letteratura ha un ruolo attivo e dinamico nel presente, educa alla problematizzazione e all’autocoscienza cioè a formare persone consapevoli, che esercitano la critica e sono libere nel pensiero. Come è solito dire: non dà risposte, formula solo domande.
Tutt’altro che piegata alla mistificazione della sua presunta collocazione in una posizione elitaria, raggiungibile solo da chi ne ha i mezzi intellettuali, lontana dalla caratteristica di evasione che un uso distorto del concetto di narrazione le affibbia, la letteratura è totalmente dentro la realtà che racconta e in quanto presente al tempo presente – anzi: presente a tutti i tempi – ha un ruolo sociale che le deriva dall’essere strumento di coscientizzazione, autodeterminazione, contestazione e rivendicazione. Uno strumento politico, insomma. Non è un paradosso. La letteratura assunta con consapevolezza indica paradigmi di resistenza e di azione. Nell’essere agente sociale e agente del cambiamento sociale, assume una posizione radicale nella dicotomia tra la logica della cultura materiale e la logica della cultura immateriale. La prima dà priorità al bene di consumo, la seconda alla crescita interiore attraverso l’acquisizione e la cura delle cosiddette capacità individuate da Amartya Sen e Martha Nussbaum. Le capacità si riferiscono alle abilità che, messe insieme, creano le condizioni per una vita degna e decorosa. Zygmunt Bauman – in Elogio della Letteratura, scritto con Riccardo Mazzeo – le sintetizza così: “La sensibilità, per esempio (avere occhi e orecchie spalancati su ciò che il mondo ha da mostrarci o da sussurrarci, su ciò che noi possiamo offrire, su quegli altri che lo abitano e ciò che avrebbero da offrire, o di cui hanno bisogno per mantenere le loro promesse); l’immaginazione e il pensiero (e, soprattutto, la capacità di mettere a frutto entrambi per vagliare le varie opzioni e operare una scelta, oltre a trovare la determinazione necessaria per mantenere fede a tali scelte, agire con coerenza andando fino in fondo); le emozioni (la capacità di amare, di prendersi cura degli altri e, al tempo stesso, ribellarsi e combattere i mali dell’indifferenza, della denigrazione, dei torti, della degradazione, dell’offesa alla dignità, dell’umiliazione); la ragione pratica (il saper immaginare un modello di vita buona e trovare la risolutezza necessaria per dedicarsi anima e corpo al suo conseguimento); la socievolezza, l’abilità e la volontà di stare insieme agli altri (il know-how necessario a condividere la vita con gli altri, e a vivere la propria avendo sempre a cuore il benessere dell’altro: il desiderio e la volontà di comprendere i rispettivi bisogni, valori e attitudini, ad essere disposti a negoziare un modus vivendi che sia mutualmente soddisfacente, nonché accettare i limiti che questo modus potrebbe porci, le rinunce che potrebbe richiederci)”.
La letteratura sta dalla parte della cultura immateriale, dell’approccio umanistico che non contempla un per sé individualistico ed egoistico, ma mette le persone nelle condizioni di accrescere il proprio Io interiore per integrarsi in una collettività sinergica, interrogante, interagente, attrice di alterità e inclusività, volitiva dell’azione e dell’immaginazione.
L’acquisizione delle capacità, però, risente del conflitto di classe, delle differenze sociali, delle condizioni imposte alle soggettività dal sistema liberista vigente. Accedere alle capacità non è immediato, non è equo e soprattutto è influenzato da tutte le storture prodotte dal capitalismo. Non tutte le persone possono permettersi di individuare il proprio percorso di vita e su di esso costruire le proprie aspirazioni e la propria felicità e questo per due ragioni specifiche.
La prima riguarda il sistema scolastico che ha oramai assunto una logica imprenditoriale tesa a formare non più cittadine e cittadini, ma imprenditrici e imprenditori. Un sistema scolastico che si disinteressa di adeguare gli insegnamenti alle esigenze di apprendimento di ciascuna soggettività. La seconda riguarda il meccanismo che regola l’istruzione, la formazione e lo stare al mondo, oggi fondato sui principi della competitività, della performance, della meritocrazia. Imprenditorialità e competitività disegnano una dinamica sociale che non prevede pari condizioni di partenza e nella quale a contare non è più l’aspirazione personale, ma il raggiungimento della ricchezza e della notorietà a ogni costo. Il sistema del capitale sembra non prevedere alternative all’essere persone ricche e famose, chi non centra questi due standard non merita un posto nella società che conta. Anzi, di più: non merita alcun posto nella società.
La mancata possibilità di trovare o realizzare le proprie capacità alimenta le sacche del disagio sociale, l’ulteriore periferizzazione dei gruppi marginali e oppressi, la convinzione che per riuscire nella vita – a riscattarsi dalla povertà, dall’ignoranza, dall’emarginazione, dallo sfruttamento, dall’analfabetismo – si debba prevaricare e applicare la legge del più forte che quasi sempre coincide con l’abilità di guadagnarsi il rispetto sulla base del proprio peso economico.
La divaricazione tra chi ce la fa e chi no è l’anima del neoliberismo con una visione binaria del mondo, dei fenomeni sociali e delle soggettività: da una parte le realtà competitive, dall’altra le realtà non competitive. Le prime si esaltano, le seconde si annientano o, semplicemente, si ignorano. In questo agone il darwinismo sociale – derivazione un po’ sporcata della teoria di Charles Darwin secondo la quale le specie si evolvono sulla base di caratteristiche che risultano più adatte di altre per sopravvivere all’ambiente – acquista le sembianze di un vero e proprio conflitto. La declinazione neoliberista del darwinismo sociale mette gli individui in concorrenza tra loro per adattarsi a una società fondamentalmente inospitale e ostile. Chi soccombe agli ostacoli che la società frappone al raggiungimento dell’adattamento – disoccupazione, povertà, ignoranza – non merita di sopravvivere perché ha dimostrato di non sapersi adeguare, di non avere le caratteristiche necessarie alla sua conservazione. Se vi venisse il sospetto che questa sia la sottotraccia della fortunata serie di romanzi The Hunger Games di Suzanne Collins e avete in testa le lotte all’ultimo sangue, allora avrete chiara anche la dinamica selettiva e utilitaristica del neoliberismo per la quale a contare è il capitale, il suo investimento, il profitto che se ne ricava, la competitività tra le soggettività e l’adattamento alle condizioni del sistema.
Essere per possedere o essere per essere. Disuguaglianza di classe e Intelligenza Artificiale
A questo punto, però, cosa c’entra la letteratura con la critica alle logiche neocapitaliste che trasformano le persone in anime di denari disposte ad annientarsi a vicenda pur di prevalere? C’entra, perché, se vale ancora quanto detto da de Staël, la letteratura, oltre a essere una replica della realtà, è anche lo strumento privilegiato per leggerla, capirla, seguirla nella sua prospettiva e dunque serve perché educa a uno sguardo critico sulla realtà, strappa all’omologazione ideologica del sistema, rivendica una posizione di indipendenza, pratica l’esercizio di discernere il buono dal conveniente. Fa una proposta di valore che è anche il modello per il compimento di un’azione politica: spezzare il circuito ideologico e mentale del consumismo per il quale si è solo nella misura in cui si compra e sostituirlo con un circuito virtuoso per il quale si è nella misura in cui si vive. Cosìsi sovvertono gli scenari reali e apocalittici del ciclo volere-comprare-buttare raccontati, per esempio, da Diamela Eltit in Manodopera.
“Sono fuori di me. Spaesato, cerco un orientamento, un qualsiasi insignificante appiglio in questa folla che mi travolge e mi urta con i suoi carrelli. E mi spinge al centro dell’arena, come se fossi un guerriero in trappola. A combattere (capisci che cosa sto dicendo, vero, ti rendi conto che mi riferisco al mio posto di lavoro). Non a combattere ma ad affrontare passivamente la belva. Ho intenzione di sottrarmi al suo ruggito. Alla fine il suo verso minaccioso è trascurabile, ciò che conta, piuttosto, sono le fauci. Le zanne, le loro lame irregolari nel mezzo di un digiuno prolungato.
(Un gruppo di famelici abitanti si è spinto fin qui, dal confine, sono magri, solo la loro trepidazione è potente).
Potrei assicurare di essere io la vittima perfetta da gettare in pasto all’arena. È proprio così, sì, la vittima (sarebbe comodo, no?) ma (sinceramente) credo di essere stato io a offrirmi volontario perché ho un disperato bisogno di affrontare le zanne; il contatto, la lacerazione, lo spettacolo finale dello smembramento (che lusso) e la caduta definitiva della mia materia. Una volta per tutte. Per quanto tempo”.
Nella disuguaglianza di classe agiscono parametri che aumentano le distanze tra il centro e la periferia, tra le fasce ricche e le fasce povere. Queste ultime, nello schema predefinito di un sistema di profitto e meritocrazia, finiscono per sentirsi estranee alle dinamiche sociali e sono condannate all’esclusione perché non offrono la garanzia di essere una classe sociale consumatrice e bancabile, cioè una classe che spende, compra e butta per tornare a spendere e a comprare senza mai provare una reale soddisfazione e senza sentirsi mai appagata. Del resto, una persona consumatrice e insoddisfatta è una persona consumatrice perfetta perché è alla continua ricerca di modelli da imitare che le diano la sensazione di essere alla moda o di possedere quello che sul mercato è un must.
Tuttavia, l’esclusione e la disuguaglianza sociali non sono prodotte soltanto da parametri materiali legati al reddito, alle pendenze penali, alla formula abitativa e alla zona in cui si vive, ma anche dagli algoritmi generati dall’Intelligenza Artificiale che mette insieme dati antropometrici, di consumo e di ricerca. Le tessere del supermercato e quelle degli altri esercizi commerciali, per esempio, non sono che strumenti messi a punto per raccogliere dati, monitorare i gusti e gli orientamenti per poi proporre, attraverso banner e messaggi pubblicitari invasivi, prodotti cercati sui motori di ricerca o che rientrano tra i propri interessi o le proprie esigenze.
Con lo scopo di profilare le persone – altro esempio – sulle piattaforme social sono stati creati filtri, giochi a quiz, prodotti per i quali si deve rispondere a domande o inserire il proprio volto all’interno di una cornice più o meno divertente. L’apparenza li rende meccanismi innocui, i colori sono rassicuranti, i layout sono accattivanti, le finalità sono goliardiche. Chi penserebbe che dietro c’è invece una diabolica macchina di profilazione? Il processo di profilazione, invece, è spietato, fa una classificazione lombrosiana delle soggettività, crea la cosiddetta discriminazione algoritmica e produce armi di distruzione matematica che “non tengono conto di variabili fondamentali, incorporano pregiudizi […]; inoltre giudicano insegnanti e studenti, vagliano curricula, stabiliscono se concedere o negare prestiti, valutano l’operato dei lavoratori, influenzano gli elettori, monitorano la nostra salute”.
L’algoritmo domina la vita delle persone, sceglie per loro, mostra prodotti che potrebbero piacere con livelli di compatibilità sempre più elevati, sincronizza i gusti a quelli di altre persone fino a consentire di trovare anche l’anima gemella. Un servizio perfetto, desiderabile, che risolve ogni problema, se non fosse che è totalmente fuori dal nostro controllo. Non c’è un campo della vita che lo escluda perché ogni azione compiuta, ogni transazione, ogni ricerca, ogni dato immesso nel sistema contribuisce alla profilazione e ad alimentare i numerosi strumenti di Intelligenza artificiale sviluppati per monitorare le persone.
Neanche il mondo del lavoro è immune dalla pervasività del sistema algoritmico, per esempio nelle operazioni di recruitment. Gli strumenti di selezione sono quanto di più razzista, misogino, omofobo e, in generale, escludente si possa immaginare poiché si basano su modelli standardizzati che tra i parametri di valutazione non includono soltanto le esperienze lavorative pregresse, la professionalità, gli studi, ma anche parametri socio-biometrici che possono riflettere e replicare i pregiudizi diffusi nella vita reale. I servizi di Intelligenza Artificiale sviluppano macchine che scremano i curricula sulla base di parole chiave o selezionano le persone dopo averne monitorato la mimica facciale, il linguaggio utilizzato, l’accento e il tono della voce.
Fay Cobb Payton, docente di Information Technology/Analytics alla North Carolina State University, afferma che gli strumenti di Intelligenza Artificiale hanno una grossa carenza di inclusività e importano nei loro modelli di riferimento un’impronta escludente e discriminatoria di alcune categorie e soggettività: donne, minoranze, comunità lgbtqa+, persone con disabilità. “Sono problematiche – afferma Cobb Payton – che creano preconcetti nel processo, prima ancora di affrontare la questione dei dati”, perché escludono su base aprioristica persone considerate atipiche, le quali vengono private dell’opportunità di ottenere un posto di lavoro in quanto appartenenti a una o contemporaneamente a più categorie emarginate o le cui caratteristiche fisiche, antropometriche e/o culturali non aderiscono ai dati socio-biometrici che costituiscono il paradigma portante.
Julia Stoyanovich, direttrice del Center for Resposible AI alla New York University Tandon e Assistant Professor di Computer Science and Engineering e di Data Science, afferma che “Gli strumenti di video analisi presentano altri problemi, per esempio il contatto visivo con la telecamera. Pensate a una persona non vedente. Non saprebbe neanche dove guardare. Pensate a una donna cresciuta in una cultura conservatrice in cui le è stato insegnato a guardare verso il basso e a non mantenere il contatto visivo. In che modo questo influirebbe sulle prospettive occupazionali?”
In che modo questo influirebbe sulla vita in generale? L’algoritmo, che per sua natura non può essere controllato e il cui funzionamento resta sconosciuto e quindi non prevedibile, tuttavia, dice Nakeema Stefflbauer, esperta di problemi etici legati all’Intelligenza Artificiale, “non è solo un problema che riguarda le minoranze o le persone emarginate che potrebbero trovarsi in situazioni difficili rispetto alla registrazione di dati, per esempio perché le telecamere non funzionano con la loro tonalità di pelle. È un problema che riguarda tutti quelli che hanno inserito i proprio dati online, ovvero la maggioranza di noi, e vorrebbero vedere trasparenza giustizia e responsabilità rispetto alle decisioni che vengono prese”.
Dal gioco perverso del controllo algoritmico non si sottraggono nemmeno i motori di ricerca. Google, ad esempio, vende a chi fa l’offerta migliore le parole chiave che permettono di rimanere in testa ai risultati di ricerca. Quando si consulta il motore di ricerca non si trova effettivamente quello che si sta cercando, ma il risultato di una compravendita che ha permesso a un’azienda di posizionarsi ai vertici della classifica. Non si ottiene ciò che serve, ma il prodotto di chi ha pagato di più per ottenere più visibilità e una migliore resa commerciale. Comprare (e vendere) pacchetti di parole equivale a manipolare il linguaggio, falsare il terreno sul quale si costruiscono i rapporti, veicolare una forma di censura che va a colpire una lunga serie di diritti: il diritto all’informazione libera e trasparente; il diritto alla libertà di scegliere consapevolmente come investire tempo e denaro; il diritto alla libertà di movimento, cioè la libertà di seguire un percorso liberamente autodeterminato e non falsato da variabili che non si possono vedere e controllare; il diritto alla privacy; il diritto di conoscere il grado di pervasività delle tecnologie informatiche e delle strategie di marketing.
Ancora una volta, che cosa c’entra la letteratura con la profilazione che l’Intelligenza Artificiale fa delle persone e con l’esclusione sociale, economica e culturale? C’è una relazione di conflitto tra la letteratura e la discriminazione algoritmica, la marginalizzazione delle soggettività oppresse, la violazione dei diritti e delle libertà individuali? Sì. Laddove tutto è merito e prestazione, laddove gli standard e i processi di selezione producono un regime di discriminazione, esclusione e pregiudizio, la letteratura è una pratica attiva e militante per superare il sistema dei parametri, dei giudizi e del voto; per superare l’identificazione della persona con un numero stabilito da asettiche ripetizioni di stringhe. Inoltre dà alla lettura – come dice la poeta, scrittrice e saggista messicana Cristina Rivera Garza – il potere di essere un atto creativo che a sua volta conferma ə lettorə non come clienti che non hanno alcun potere di agire sul testo e sulla storia, ma come complici, co-creatorə, co-autorə che possiedono l’ultima parola che chiude la storia.
In un sistema di ipertrofica perfezione in cui chiunque o riesce o non è, la letteratura costituisce la pietra di inciampo, l’imperfezione, il difetto, la sbavatura che prevede la possibilità del fallimento, il luogo dentro il quale – scrive Olga Tokarckzuk ne I vagabondi – “Non lasciare nessuna situazione inspiegata, non detta, nessuna porta chiusa; sfondarla a calci con una parolaccia, anche una di quelle che conducono a corridoi imbarazzanti e vergognosi, che sarebbe meglio dimenticare. Non vergognarsi di nessuna caduta, di nessun peccato. Il peccato raccontato viene perdonato. Una vita raccontata e una vita salvata. Chi non ha imparato a parlare rimarrà per sempre chiuso in trappola”.
Nella letteratura che si oppone a un sistema economico, sociale e culturale precostituito e imposto come unica alternativa è in atto una rivoluzione delle idee e dei costumi; è in atto la rivendicazione di indipendenza di autonomia; è in corso una dichiarazione manifesta di libertà e un processo di liberazione del pensiero, dell’azione, del sentimento. Questo è il modo della letteratura di legarsi alla realtà definitivamente che narra e rappresenta e di agire su di essa.
Vivere una quotidianità rivoluzionaria, correre il rischio di difendere la propria integrità, la propria indipendenza, la propria libertà, non è un prezzo che si debba pagare come se costasse sforzo sceglierlo, ma una lotta da rivendicare come unica opzione possibile.
Al partigiano Aldo Chiantella un giorno ho chiesto perché abbia deciso di unirsi alla Resistenza. Lui ha dato la più rivoluzionaria delle risposte: perché non c’era alternativa. Aldo Chiantella, nell’aderire alla lotta di liberazione, nella sua testimonianza è stato come il bucaneve della poesia di Louise Glück: “Non mi aspettavo di sopravvivere,/con la terra che mi schiacciava. Non mi aspettavo/di svegliarmi, di sentire/nella terra umida il mio corpo/capace di rispondere di nuovo,/ricordando/dopo tanto tempo come riaprirsi/nella luce fredda/della primavera agli albori:/impaurito, sì, ma di nuovo fra voi/gridando sì, rischiare la gioia/nel vento aspro del nuovo mondo”.
Nè Chiantella, né il bucaneve hanno conosciuto la prudenza; non hanno vissuto a metà soccombendo alla paura; non hanno rinunciato a impegnare le loro vite.
Non hanno avuto rimpianti per questo.
Ti è piaciuto questo articolo? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

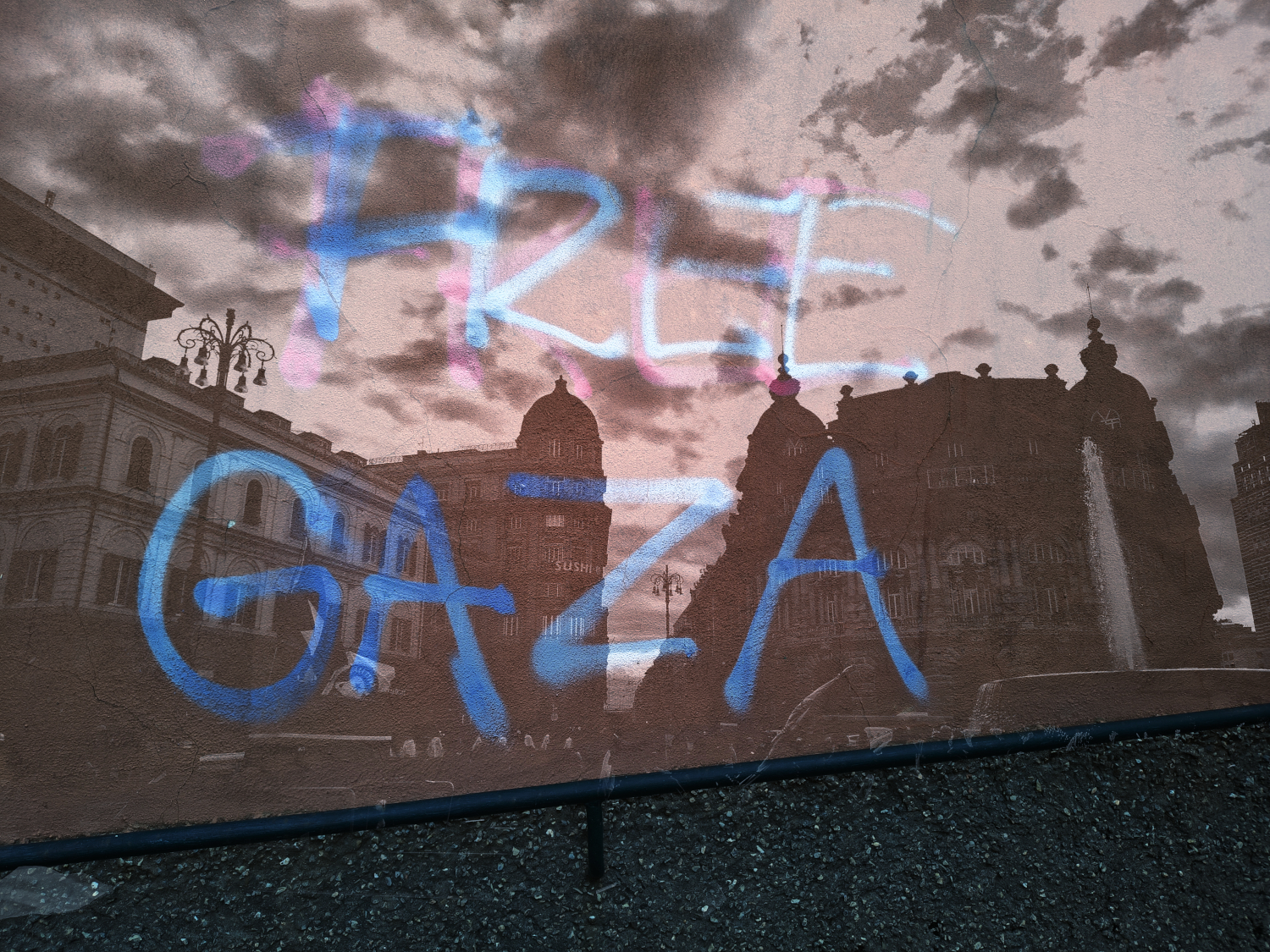
Siamo in resistenza
Viva i libri!
Viva la letteratura!
Nessun’altra alternativa.
Oggi come sempre è urgente avere la forza, la lucidità e il coraggio di fare come Chiantella e il bucaneve.