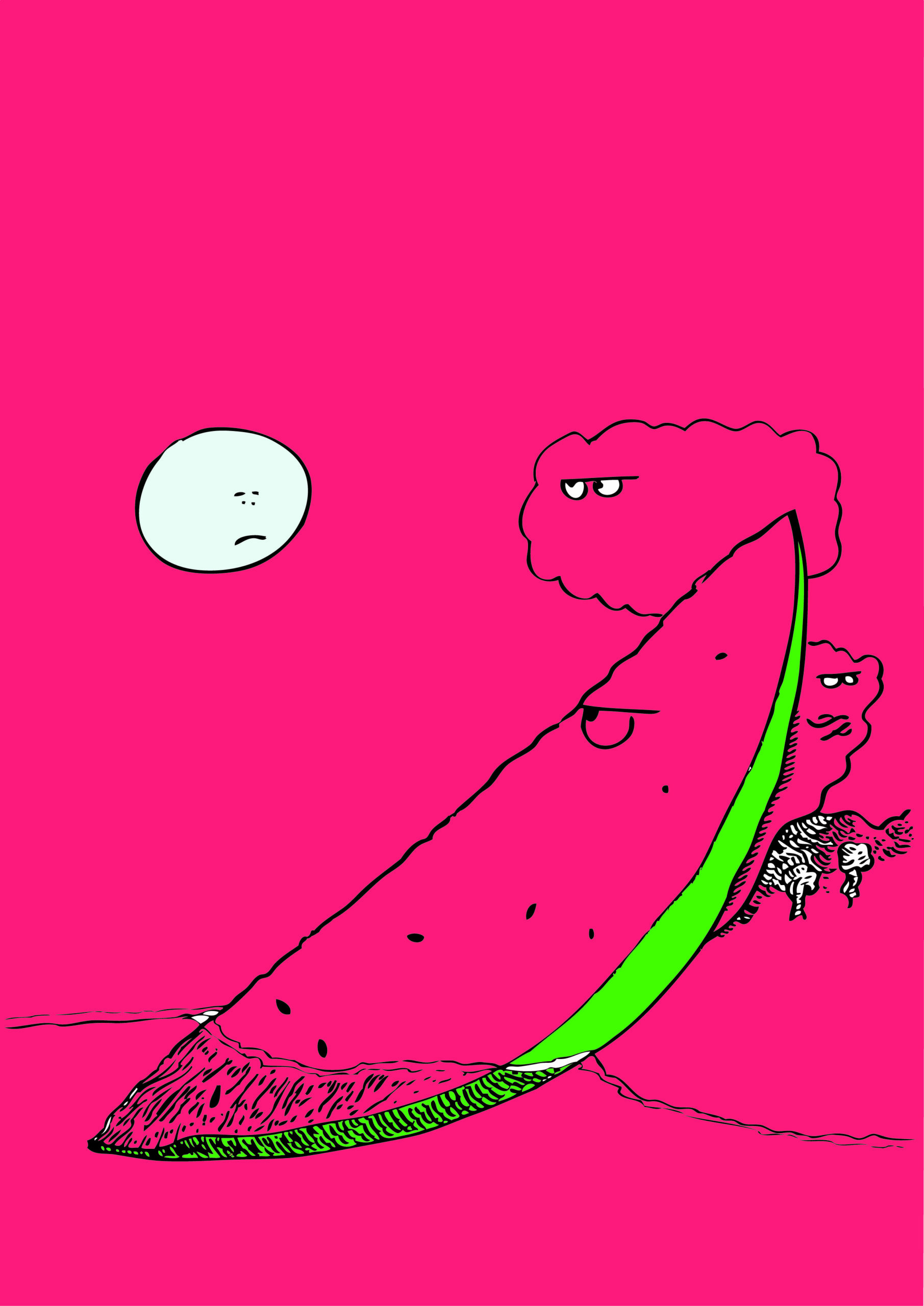di Giacomo Cavaliere
Copertina di Luca Skuyatulek
La maggior parte delle cose brutte che ho fatto, le ho fatte dopo tutta la storia. La prima è stata quella delle bombolette. Quella che mi è hanno fatto pagare di più e con più gusto, di sicuro non la peggiore.
Potete farvela raccontare da chiunque, a Saint-Étienne-du-Rouvray, e ogni volta ne sentirete una diversa. I giornali hanno raccolto quello che di solito interessa ai giornali, e su internet, un commento alla volta, milioni di voci e vocine ci hanno costruito sopra la saga. Non dovete per forza credere alla mia, di versione, ci mancherebbe, ma vi consiglio di assemblare la verità tramite le parole di gente del posto. Non per forza Saint-Étienne, Saint-Aubin, Tourville, o in uno delle altre ville dimenticate dal signore a sud di Rouen, solo non in un’altra nazione.
Tutto è iniziato con la signora Laporte – questo è indubbio –, una donna che viveva per sapere cosa facessero gli altri. Per correggere le loro vite sbagliate. Punirli, quando poteva. La maniera più efficace per dirottare la vita di un altro essere umano, specie se innocente. Io le abitavo di fronte e di me sapeva molto più di quanto chiunque avrebbe mai dovuto.
Qualcuno continuava ad entrarle in giardino o, almeno, lei ne era convinta. Avrebbe potuto far alzare le siepi o la ringhiera di cinta, ma solo a costo di rosicchiare il proprio orizzonte e accorciare il tiro utile dei suoi occhi. Non si sarebbe mai rassegnata a farsi accompagnare alla morte dalla televisione. Un tale aveva deciso di buttarsi sotto al treno, perciò, quando telefonò alla gendarmerie per denunciare l’ennesimo scavalcamento della sua staccionata, gli unici due agenti in stazione le dissero che non potevano muoversi. Lei starnazzò indignata che nessuna polizia al mondo avrebbe mai concesso tante ore di licenza alla delinquenza, poi chiese quale genere d’evento sarebbe riuscito a imporgli di muoversi. Se la questione è grave, si corresse l’agente imberbe che aveva raccolto la chiamata, possiamo avvertire i colleghi di Rouen. La signora Laporte rispose offesa che sarebbe stato meglio per loro. Vecchia stronza, concluse certamente l’agente, sbattendo la cornetta.
Cinque anni prima, l’attenta perseveranza di madame Laporte nel segnalare le più piccole scorrettezze dei cittadini di Saint-Étienne-du-Rouvray era stata premiata dal sindaco con la coccarda inaugurale del neonato conferimento agli elementi più attivi della comunità. Dal primo piano della sua abitazione permise l’arresto in flagranza di una banda di ladri d’appartamento durante le ruberie estive, alla fine di uno diluvio di segnalazioni fasulle. La signora Laporte offriva un ventaglio di servizi anche più ampio: dalla segnalazione di recidivi del divieto di sosta, ai nomi e cognomi dei ragazzini che imbrattavano l’arredo urbano e disturbavano il vicinato; comprese ripetute delazioni riguardo all’unica armeria che vendeva petardi ai minorenni. La successiva edizione del premio, la prima intenzionalmente organizzata, non vide altri rivali. Stavolta, le autorità ritennero di premiarla con qualcosa di più di una colonna nella pagina di cronaca del bollettino della parrocchia e una spilla di stoffa. Stamparono una targa commemorativa di latta con inciso l’encomio per i cittadini che, con passione, sacrificio e abnegazione, promuovono attivamente per il benessere della loro comunità. Non vennero organizzate altre edizioni. Aveva preso l’abitudine di seguire individui sospetti e, in almeno un caso, le sue interminabili sequele di segnalazioni arbitrarie, erano riuscite a concretizzarsi nell’arresto di uno spacciatore residente in paese che conoscevo di vista. L’ondata di fermi di tossici minorenni, prima di arrivare a lui, travolse anche me. Subito dopo aver riattaccato con la gendarmeria, di solito, se dubitava che la sua parola non fosse stata efficace o, a maggior ragione, quando era convinta di esserlo stata, prendeva l’elenco e chiamava a casa i genitori dei ragazzi che non era riuscita a a far arrestare. Le punizioni di casa erano spesso più efficaci, e impietose, se il genitore era quello giusto e votava nella stessa direzione di madame Laporte.
Questa era la prassi, anche se non eravamo molti fra i bianchi ad essere odiati quanto i neri. Quegli altri, per lei. Più di tutti ce l’aveva con gli arabi, e, per lei, quasi tutti i non-cristiani della terra erano, di fatto, arabi.
Era già una donna molto anziana quando le istituzioni si accorsero di lei. Fino a quel momento, per quelli abbastanza vecchi da ricordarsene – vale a dire l’ottanta percento di un paese di ventottomila abitanti – era stata soltanto la squinzia del prete. Forse più d’uno, sibilavano le lingue più velenose. Ho sentito dire che quel prete fosse tornato da poco, a ottantasette anni suonati, alla chiesa di Santo Stefano, dopo un lungo trasferimento tra le parrocchie del sud. Venne allontanato per punizione, forse per sottrarlo alle attenzioni di un paese in cui non erano solo i preti a sapere tutto di tutti; e, sempre per punizione, a fine carriera, ce l’avevano riportato. La figlia del commercialista di mio padre, che andava a messa la domenica, mi inviò un articolo a proposito di un prete della diocesi di Arles, ritornato nella natia Normandia a seguito del polverone sollevato dai suoi sermoni anti-immigrati.
Madame Laporte frequentava la chiesa assiduamente, leggeva il bollettino della parrocchia, il giornalino del paese e La Croix, quando capitava, aveva sempre la tivù accesa su un dibattito in cui tecnici e illuminati di varia natura tuonavano verità incontestabile sul mondo e le cose di cui era fatto. Cose alle quali commentava con veemenza, inveendo contro le immagini in movimento. Nessuno dovrebbe permettersi di suggerire la superiorità di una confessione su un’altra, né di un uomo su un altro, cose di questo genere la facevano infuriare al punto di limitare la risposta diretta a poco più di un vaffanculo. Poi, abbassava il volume e si rivolgeva ai ritratti incorniciati dei generali De Gaulle, Salan e Leclerc, che dissentivano con alterigia dandole manforte dalle pareti color senape del salotto. In città, i bambini bianchi quasi non esistevano più, risicata minoranza di giannizzeri in un’armata di turbanti – e non perdeva occasione di rimarcarlo, che fosse sola o davanti a qualcuno che annuiva.
Pioveva da tutto il giorno – il giorno scelto per cominciare la storia. Telefonò alla forza pubblica una dozzina di volte, così che non potessero dimenticarsi, fornendo accurati resoconti di ciò che la loro assenza la costringeva a fare da sola. Citofonarono al civico ventidue di Rue de Bourguignons con tutta la calma del mondo, non molto prima di cena. Riconobbe gli agenti e loro riconobbero lei. Madame Laporte abitava in quella casa da tutta la vita; una villetta a due piani con mansarda arredata, porticato di legno, due cortili e un garage che non aveva mai visto un’auto da quando suo padre era morto.
Aprì il cancellino e pregò dal citofono di richiuderlo appena entrati. I due gendarmi percorsero il vialetto di pietra che attraversava il giardino fino alla porta d’ingresso. Non volle farli entrare e li lasciò sotto al porticato. Aveva ripreso a piovere, la giornata stava finendo e non avrebbe certo visto altra luce.
La casa è rimasta chiusa da ieri sera, disse. Non ho fatto spesa e nemmeno sono uscita per altre compere. Solo per portare dentro lo stendino, stamattina presto. Chiunque sia è lì fuori, sentenziò puntando l’indice contro la scritta gendarmerie sul petto dell’agente più anziano, per indicare il mondo alle sue spalle.
Cosa è successo, signora Laporte?, domandò lui.
È da stamattina che vedo gente nel mio cortile. Scavalcano, rovistano nella spazzatura, sono persino entrati in garage, qualche giorno fa. Sono quei ragazzini che vogliono vendicarsi. Spacciatori arabi, come li chiamate? L’ho letto sul giornale, neanche tanto tempo fa, hanno proprio un nome, quei pazzi?
ISIS, forse?
Sì, esatto, sono loro!
Posso garantirle di no, signora Laporte.
E come fa a dirlo? Non sa nemmeno chi sono!
Cosa hanno rubato?
Niente, non ci tengo niente in garage.
I gendarmi lasciarono il sentiero di pietra e impressero le loro impronte nel prato fradicio. Percorsero il profilo della casa per pura rappresentanza, tenendo in canna tutto quello che avrebbero detto della signora appena risaliti in macchina.
È capace di chiamare altre dieci volte prima di mezzanotte, e altre dieci durante la notte, commentò il sergente quarantottenne precocemente stempiato e d’indole piuttosto buona. La recluta sbarbata accanto a lui era lo stesso che aveva raccolto la telefonata, gli voleva bene, se anche era quel genere di bene che raramente usciva dall’ambito professionale. È terrorizzata dalle palazzine degli arabi, disse alla fine, per sottolineare l’ovvio.
Li capisco, però, poveri vecchi. Con tutti questi arabi in giro che vengono da chissà dove, rispose l’altro con tutto il candore di chi riesce a dividere con successo il mondo in assoluti senza sfumature.
Sono cinquant’anni che dobbiamo avere paura degli arabi, è così che funziona il terrorismo. Dai tempi dell’Algeria e dell’OAS. Non basterebbe neppure la paura degli arabi, non sono mica tutti arabi i terroristi. Solo in Bangladesh ci sono centosessantacinque milioni di persone, quasi tutti musulmani, e non è nemmeno il più popoloso. Non possiamo avere paura di tutti i musulmani. I terroristi non sono mai venuti dalla Siria o dallo Yemen, ce li siamo coltivati in casa fin da piccoli, a Saint-Denis, Molenbeek, ma qui a Saint-Étienne-du-Rouvray non ci sono terroristi, solo spacciatori, qualche stupratore, criminali di basso livello, gente che vive d’espedienti, tentò di argomentare il sergente.
Però la vecchia ha ragione. Potenzialmente, lo sono tutti. Ha sentito l’altro giorno al Louvre?
No.
Un ragazzo, si è scoperto con gravi problemi mentali, recentemente dimesso da un istituto, si è presentato alle casse e ha gridato Allahu Akbar, ha estratto la mano dalla tasca impugnando un coltello. Non un coltello da caccia o un coltellaccio da cucina, un coltello qualunque, un serramanico o qualcosa del genere. Uno dei paracadutisti impegnati nel presidio l’ha visto e gli ha sparato. Un solo colpo, in mezzo a centinaia di persone, nel bel mezzo del mattino, dritto in faccia al tipo. Quello è caduto lì dov’era e non ha più ripreso i sensi, anche se ci ha messo qualche giorno a morire.
Perché me lo racconti, Thierry?
Ha letto le circolari del Ministero. Prima sparare, poi chiedere.
Non hanno mai detto niente del genere.
Dicevano di non rischiare niente. In situazioni del genere, per evitare altri massacri, è opportuno usare una dose di forza neutralizzante.
Per questo ci sono i paracadutisti e le forze speciali a presidio dei siti più sensibili. Tu devi parlare con le persone e tenere la pistola in tasca. E smetti di leggere qualunque cosa tu stia leggendo.
L’auto deviò dal percorso di cinquecento metri per necessità retoriche, la mano del sergente indicò i palazzoni color pastello d’edilizia popolare concepiti per nuclei di quattro, cinque persone, stipati di famiglie bengalesi, cingalesi, maliane e algerine con dodici figli.
Negli ultimi tre anni la città ha guadagnato quattromila cittadini. Siamo quasi a ventinovemila, spiegò il sergente.
E sono tutti neri.
Non tutti, ma tanti. Tu e la signora Laporte avete la stessa orticaria, mi sa. Sei giovane per essere già così incazzato.
A me frega poco, dico solo che la capisco, e mi dispiace per lei. Per tutti gli anziani. Erano abituati a vivere in un paese completamente diverso, tra persone come loro, e ora si vedono costretti a morire in un posto che somiglia più a Mogadiscio che al luogo in cui sono nati e cresciuti. Sporco, pericoloso.
Ma dove cazzo lo vedi il pericolo? Ad ascoltarti sembri tu quello che vive a Mogadiscio. Quanti reati gravi hai perseguito? Quanti delitti, quante rapine a mano armata? Un giorno faranno una pomata anche per i vostri pruriti, piccolo.
Non mi fraintenda, capo, per me i vecchi dovrebbero abbatterli tutti da piccoli, però forse un giro dovremmo farcelo, abbiamo cinque o sei indirizzi a cui citofonare. Giri qui a sinistra, capo.
Stai zitto.
Il sottufficiale anziano non raccolse l’invito, e proseguì dritto. Lo so dove vuoi andare. Raju Nahar ha la cavigliera elettronica ed è sotto sorveglianza del tribunale, so che è casa, non ho nessuna voglia di farmi insultare da sua madre e dai vicini per verificare qualcosa che so già. Qualcuno ti sputa, tu tiri fuori il manganello, magari qualcuno finisce giù per le scale, magari tu. Così cominciano le rivolte. Nahar è un delinquente, non un coglione, non rischierebbe di finire in galera per spostare i vasi a una vecchia psicopatica. Non ci andiamo, basta, per oggi il pane ce lo siamo guadagnato. Aspettiamo che qualcuno faccia qualche stronzata.
La volante della polizia sfilò accanto al complesso popolare che raccoglieva la maggior parte degli indirizzi, veri o presunti, enumerati nei raccoglitori destinati ai delinquenti magrebini. Una decina di parallelepipedi di dodici piani color mattone, senza mattoni, ma con le facciate piastrellate.
La signora Habiba aveva sfornato sette figli in dieci anni, era abituata ad avere la casa e tavola intasate di bambini e adolescenti refrattari alla crescita. L’occhio le cadde naturalmente giù dalla finestrella della cucina, aperta anche d’inverno per lasciar sfiatare l’odore e non intaccare le tende del salotto. Ogni volta che l’ansante respiro diesel delle volanti della Gendarmerie risaliva dalla strada, non riusciva a non sbirciare di sotto. L’ultima volta se ne era trovate cinque, sirene e lampeggianti accesi, convergenti come i lati di una freccia verso il portoncino del palazzo. Cinque volanti per un ragazzino minorenne. Pensò che avesse ucciso qualcuno e, nella disperazione, aveva trovato il modo di apprendere che non avrebbe avuto occasione di ucciderlo lei.
Riuscì a inquadrare il retro della pattuglia che procedeva piano, sicura che avessero alzato gli occhi verso le finestre dell’interno al sesto piano che avevano rivoltato più di una volta. Mamma Habiba era originaria della Mauritania, figlia di rifugiati tuareg scappati a Bonifacio prima della rivolta del novanta. Aveva poco più di trent’anni, ma cominciava solo ora a prendere coscienza dell’età. Prima non aveva avuto modo di rifletterci, avere vent’anni o dieci non aveva mai fatto alcuna differenza; ora che suo marito non c’era, stava sviluppando la strana paura che i figli potessero raggiungerla e trovarsi coetanei. Improvvisamente s’era sentita giovane, e non sembrava affatto trovarsi a suo agio in quella nuova, smaritata consapevolezza. Shamim aveva venticinque anni più di lei e, al contrario di lei, veniva da un posto in cui era qualcuno. Perciò, era naturale che mancasse da casa da così tanto tempo. I soldi arrivavano, uno stipendio abbondante, in euro. Era tornato a Dacca cinque anni prima, ma non aveva mai smesso di chiamare, anche se chiamare lui era praticamente impossibile. Ovunque fosse, un marito, restava sempre un marito. Almeno due figli sono sistemati, si ritrovava a pensare ogni volta che gli schiamazzi della cameretta filtravano dalle pareti. Quella camera era la fossa dell’harām. Una testa calda capita in ogni cucciolata. Raju sarebbe un bravo ragazzo, se smettesse di rubare e di vendere quelle schifezze, pensava, cercando di accordare il pensiero nella nota della speranza. Era sempre più difficile trovarla.
Raju, il figlio mediano, aveva ancora otto mesi di detenzione domiciliare da scontare prima che gli rimuovessero la cavigliera elettronica. In casa abitavano due gemelli di undici anni, un maschio e una femmina; il primo figlio era tornato in Bangladesh da suo padre per sposarsi, il secondo era riuscito ad aprire una piccola attività a Tampere dove viveva uno dei fratelli di suo padre, un altro era soffocato tre giorni dopo la nascita e l’unica femmina se l’era portata via la meningite a otto anni. Colpa di un medico francese che non la ricoverò finché Habiba non riuscì a farlo sentire un verme chiedendogli in quale cassonetto avrebbe dovuto gettarla. Fuori casa nessuno chiamava suo figlio Raju, per tutti i suoi trentaseimila follower lui era solo The Rap Mullah. I videogiochi cabinati erano senz’altro il complemento d’arredo più costoso della camera che divideva coi gemelli e altri due inseparabili amici – secondo i precetti della west-coast che imponevano a ogni rapper del mondo di muoversi e giocare ai videogame con più persone possibili.
Aduan, Marwan e Raju erano tumulati in cameretta – il più grande dei quattro vani che componevano gli ottanta metri quadri dell’appartamento –, obliati dalle sensazioni offerte dall’universo on-line di Grand Theft Auto combinato con erba e Subotex.
Un cecchino al millesimo piano di un edificio inquadrava bersagli in strada, il puntatore si spostò su un aereo di linea che faceva la barba a un altro grattacielo e che il gioco non permetteva di abbattere.
Ma davvero tuo fratello sta tornando?, domandò Aduan, quindici anni, il più piccolo, stolto e per nulla coccolato del trio. È iracheno, l’unico a non essere nato in Francia, ma aveva poco più di due anni quando si è trasferito. Tra poco è il mio turno, sentenziò Marwan. Fisico da centometrista, muscoli d’ebano tracciati a matita, l’intensità del suo incarnato non permetteva di capire che anche lui era un meticcio, benché privo di evidenti sfumature di colore. Madre Yoruba e padre ignoto. Un potenziale campione d’atletica, non avesse incontrato l’eroina e le ragazze. Era il più grande, diventato amico di Raju in virtù del legame con suo fratello maggiore Nassan, quello tornato in Bangladesh per trovarsi una brava moglie e mettere la testa a posto. Uno dei due che ce l’avevano fatta.
Quello promette di tornare da quanto, due anni? Ma chi glielo fa fare?, continuò Aduan.
Nessuno, vi dico, per questo non torna, e neanche dovrebbe, spiegò Marwan con fare pedagogico, aspirò la canna e allargò un ombrello di fumo sul faccione accigliato dell’Ayatollah Khomeini appiccicato alla parete. Lui e la Suprema Guida si guardarono negli occhi, ma lui li distolse per primo, distratto dagli angoli logori e dallo scotch di carta che stava scollandosi dalla parete. Dì un po’, ma tu lo sai chi è questo? Chi è tuo padre, tu che ce l’hai? Questo poster bisogna che sparisca, e anche quello. Marwan stese il suo possente braccio accusatore verso la parete opposta, ricoperta di graffiti multicolore, sulla quale era attaccato il faccione sorridente di Nasser.
Mi sa che mio padre lo conosci meglio tu. Raju non distolse lo sguardo dalla carneficina che stava consumando sullo schermo.
A Rouen lo chiamavano shaykh. Non è un titolo che si ottiene così, è la comunità che deve riconoscerti shaykh. Ha fatto una gran cosa. Ci vuole coraggio per lasciare la propria vita qui in Europa e ritornare nella propria terra. E anche…
Aduan fece per parlare, ma fece appena in tempo a pronunciare le sillabe di Raju, che subito lo zittì. Porca troia, quante volte ti ho detto che non voglio che mi chiami così. Sono il Mullah, ok? Cazzo, è tanto semplice… Che vuoi?
Hai finito di montarlo?
No, ancora no. Questo è difficile.
Perché, che hanno fatto?, continuò con bramosa fame di dettagli dopo aver premuto il tasto pausa.
Hanno riempito una gabbia di prigionieri libici, lealisti di Gheddafi, milizie di Misurata, gente di Haftar, e l’hanno portata in un parco acquatico abbandonato. Credo. Comunque un posto con una grande piscina olimpionica. L’hanno riempita d’acqua, montato telecamere subacquee e, con una gru, ce li hanno calati dentro. Poi, ne hanno portati venticinque su una spiaggia di Sirte e fatti inginocchiare sulla battigia, all’alba, e venticinque miliziani hanno tagliato una testa ciascuno. Ma da montare è un macello, dieci ore di girato e un miliardo di inquadrature.
Ma da dove arrivano?
Dalla Libia, idiota. È lì che adesso si combatte il vero jihad, intervenne Marwan.
È tuo padre che te li manda?
Marwan lo colpì sulla nuca. Vattene a casa, è tardi. La signora non può cucinare per te tutte le sere.
E tu, allora?!
Io non mangio, veglio su di loro mentre lo shaykh non c’è. Fuori dalle palle.
Aduan puntò la porta a testa bassa, salutò ossequioso la signora, rimise le scarpe e uscì.
Cristo, non so come fai a sopportarlo.
Siamo amici da piccoli. Ha la mia età e hai visto com’è conciato?
Gli stupidi sono pericolosi… Allora, hai chiamato Nassan, è in viaggio?
Sì, l’altro ieri era a Ioànnina, sono andato a cercare su Google dove fosse.
È in Grecia, disse Marwan.
Ci sta mettendo un secolo a tornare. La Siria non è così lontana.
Cosa dirai a tua madre?
Che ne so, quella è una volpe, una serpe, ha ragione mio padre. Sono sicuro che sa tutto.
Ho mandato dei ragazzini a spostare i vasi della vecchia, oggi. Voglio vedere se trova le differenze.
Tutte le vecchie sanno che si scopava il prete, questo qui che è tornato, anche se non frega più a nessuno. E intanto fa arrestare i ragazzini. Hai sentito del fratellino di Yassin? Dodici anni. Sette ore in caserma prima di poter chiamare sua madre, per aver scassinato i parchimetri del centro commerciale Saint Martin, ringhiò Raju infilando una mano sotto al letto per estrarre una scatola di scarpe. La aprì e rollò un altro spinello.
Sono andato ad ascoltare il prete.
In chiesa?!
Taqiyya, sai cos’è? Un musulmano può bere, fumare, mangiare maiale e persino non digiunare, per mescolarsi ai kuffar. I peccati dello shahīd saranno tutti perdonati. Ha parlato di un film americano sui missionari gesuiti torturati dai giapponesi, nel cinquecento, di cristiani che devono professare in segreto ancora oggi per sfuggire alle persecuzioni in Nigeria, Ciad, e altri posti così. Ha detto che il mondo di oggi, per la brava gente cristiana, non è più un luogo sicuro e che, purtroppo, molti sono stati costretti a impugnare le armi per difendersi come a suo tempo fu costretta fare la brava gente del sudamerica per proteggersi dai comunisti.
Hai ascoltato bene, vedo. È già una settimana che Nassan è in viaggio. Chissà quanto ci metterà, è chiaro che non sta venendo qui.
Cosa vuoi dire?
Che quello che Nassan deve fare non lo viene a dire a me.
Posso farlo io con Aduan. Se gliela vendo bene mi seguirà. L’ultima volta l’ha fatto.
Era un negozio cinese, e la pistola era scarica. Accetterà di morire da martire, secondo te? La stupidità si ferma all’autoconservazione.
Quando sarà, non potrà evitarlo. Ho tutto quello che serve. Telecamere, microfoni, vestiti, e ho riempito altri tre tubi da due pollici di perossido di acetone. Sai che sono diventato bravo a farli. Sono passati sei mesi da quando ho rubato quelle munizioni dai Maloudant e qui non è venuto nessuno. Tu hai quello che mi manca. È tutto preparato da un mese, avrei potuto farlo una settimana dopo che è partito, ma mio fratello mi ha detto di aspettare. E ho aspettato, ma adesso mi sono rotto.
Ho solo un vecchio pezzo polacco.
Una basta.
Vuoi davvero farlo?
E quale alternativa ho, dentro e fuori di galera? Inshallah, se è quello che vuole, io sono pronto.
Non sai nemmeno leggere l’arabo, Raju.
Imparerò. Dopo.
Se aspettassimo Nassan, potremmo usare i suoi contatti in Siria e in Bangladesh per ottenere più roba. AKM, vz. 58, magari qualche AK 105 o addirittura versioni più recenti. Magari europei.
Li possiamo trovare anche noi. Dagli stessi francesi bianchi del cazzo che ti hanno venduto quella roba polacca. Basta pagare, ma a me non frega un cazzo degli AR-15. Al tunisino è bastato un furgone.
Cosa dirai allo stupido?
Che hanno catturato mio fratello, e devo fare qualcosa per aiutarlo a farlo evadere, una stronzata del genere. Magari niente. Conosce solo il Corano, la fame e GTA. Una volta che saremo in ballo, ballerà. Domani non è domenica?
No, perché?
A che ora fanno le messe?
Non provare a passare dalla signora Laporte. Non inquinare l’opera di Allah con le tue questioni personali. Adesso non puoi permettertelo.
Mai, mi permetterei. Io sono un mujāhid. Portami tutto, e domani mattina tieniti pronto a postare.
Vuoi farlo domani?!
Prima. Stanotte.
Durante la notte venne giù il diluvio, ma la signora Laporte, avviluppata in una vestaglia di pile il ventisei luglio, alle quattro e quarantacinque del mattino, uscì per controllare che i vasi non fossero allagati. Lo erano. Bloccò la porta con un pezzo di legno per non doversi portare dietro le chiavi nell’ispezione quotidiana del perimetro della proprietà a lume di torcia, tra la prima minzione e il caffelatte. Le gambe ingessate dall’artrite allungavano la procedura. Ancora inebetita, strisciò i piedi in cucina; per nulla rinfrancata dal sonno, aprì lo scomparto del mattino del dispenser di pillole giornaliere color verde mercoledì e allineò sette pillole sulla tovaglia. Alle sei meno venti, la zuppa di pane squagliato nel latte non era ancora finita. Non sopportava i rumori di prima mattina, perciò non regolava l’apparecchio acustico fino a dopo colazione. Non sentì la finestra né poté notare il cavo reciso dell’unico telefono di casa. Il braccio nero del Mullah attraversò l’inquadratura della body-cam allungandosi verso la leva del salvavita. L’acquazzone impediva al sole di sorgere, lo scatto del contatore fece precipitare di nuovo la casa nelle profondità di una notte non ancora del tutto smaltita.
Madame Laporte aveva sembra una torcia a portata di mano, una di quelle grosse, con una maniglia per essere impugnate come valigette a forma di piccoli e tozzi siluri capaci di sprigionare migliaia di lumen. Appena varcato l’arco del salotto, notò la fila d’impronte fradice davanti alle quali era appena passata senza vederle. Le seguì con la torcia fino all’ometto nero raggomitolato dietro il divano. Liberò la testa coperta da un passamontagna senza buchi per bocca e naso ma la luce lo costrinse a riportare lo sguardo al pavimento. Nell’alzarsi rovesciò il comodino che sorreggeva una abat-jour. Nel vedere quella macchia nera alzarsi e farsi uomo si sentì raggelare. La gola si sigillò nello sforzo di un urlo che uscì come poco più uno squittio. Il Mullah era alle sue spalle, caftano nero fino alle caviglie avvolte in un paio di verdi anfibi militari, guanti da sub, il braccio sinistro infilato fino al gomito in una federa di cuscino fradicia, in testa un elmetto in teflon da softair e un passamontagna identico all’altro.
I polmoni di madame Laporte risucchiarono una vampata d’ammoniaca, le mani avvizzite si strinsero attorno all’avambraccio del Mullah, le unghie tentarono invano di affondare nella stoffa nera. L’artrosi bloccò ciascuna falange a novanta gradi senza che potesse imprimere alcuna forza, come avesse una crisi epilettica. Qualche secondo di danza appena accennata sul posto e, allentata la presa della federa sul volto, madame cadde come cosa morta. L’urto col parquet e la fame d’ossigeno la rianimarono quasi subito. Tutta la vita disponibile le si condensò in bocca e prese il suono di un rantolo. Il ragazzo premette leggermente il ginocchio sul ventre, senza caricare il peso, e le adagiò delicatamente l’altra mano sul volto cercando di non farle altro male. Erano le sei e zero uno e, nel quartiere, non c’era nessuno altrettanto ficcanaso e mattiniero. Non urli, madame, la prego. Le ho scritto una cosa da dire.
Il Mullah aggiustò l’inquadratura e le allungò un foglietto con la shahādah traslitterata e tradotta: lā ilāha illā Allāh wa Muhammad Rasūl Allāh. Non v’è divinità all’infuori di Allah e Maometto è il suo Messaggero. Si metta in ginocchio, chieda scusa per tutti i problemi che ha causato ai ragazzini musulmani innocenti del suo paese, chieda scusa per tutte le volte che ha fatto svegliare una madre di notte dalla polizia perché qualche bambino l’aveva guardata male, chieda scusa a tutti i bambini che ha fatto prendere a schiaffi dai poliziotti, per tutte le bugie che si è inventata, per tutte le vite che ha rovinato. Giuri, si sottometta, chieda all’Unione Europea e al governo francese di interrompere gli attacchi in Siria e Iraq, e, forse, si salverà.
Ma chi siete voi, sporchi… Aiu…., la federa imbevuta d’ammoniaca la zittì.
La mano si strinse attorno al collo. Strinse ancora, un poco di più, e la sollevò. Lei tossì e un conato la strozzò. La mise su un fianco per aiutarla a liberare lo stomaco mentre richiamava Aduan dal torpore. La trascinarono al centro del salotto. Comincia tu, ordinò il Mullah. Aduan impugnava il coltello da sub come un bambino stringeva la forchetta; sigillò le pupille con tanta forza da fondere la pelle.
Ma il video? Dobbiamo farla parlare!
Hai la tua bodycam.
L’ammoniaca e l’ipossia l’avevano resa inerte, dalla bocca fuoriuscivano poco più che lamenti, ma Aduan era sull’orlo delle lacrime. Lasciò che cadesse in ginocchio. Gli ordinò di estrarre il coltello. Avevano tutto il tempo, anche troppo. Se la presero comoda, sono riuscito a vedere il filmato originale, quello vero. Hanno impiegato settimane per eliminarlo da internet, ma su Telegram gira ancora. Una cosa lunga, tre quarti d’ora, giù di lì, con tanto di dichiarazioni riprese dai video di Jihadi John. Fu il Mullah a leggere tutte le dichiarazioni. Raju la tirò su per le ascelle, lei abbandonò il peso contro di lui, i talloni fregarono il pavimento. Il polso sottile di Aduan sì piegò innaturalmente in avanti in un affondo lentissimo. Quasi volesse sentire la tenacità della carne, ma, tra i guaiti, una chiazza di saliva s’allargò nel passamontagna.
Quando i rumori si fermarono e non rimase che il respiro affannoso imprigionato tra le pareti, il Mullah chiese ad Aduan se avesse portato la sparapunti. Raccolsero la telecamera e inquadrarono il macello, frugarono nella borsa e il Mullah lo crocifisse di insulti per essersi dimenticato le uniche cose di cui avrebbe dovuto ricordarsi. Impiegarono un po’ a cercare un sostituto, finché dovettero rassegnarsi a ficcare la coccarda di cittadina modello nella bocca di madame Laporte. Aduan la posizionò al centro del tavolo nel patio davanti, parzialmente riparato dalle tende che scendevano dalla tettoia.
Prima di risalire in auto, il Mullah dovette indossare un kaftan nera di ricambio. Parcheggiarono sul sagrato della chiesa di Santo Stefano. La messa era iniziata da un quarto d’ora, ammesso fosse iniziata in orario. Aduan si posizionò all’entrata, riparato dietro la colonna. Immerse la bocca del RAK nel liquido che stagnava nell’acquasantiera, in mano sua pareva pesare come una doppietta. Raju aveva steso il calcio e la particolare impugnatura sotto la canna, prima di fargli vedere dove fosse la sicura e dirgli chiaramente che fosse pronto a sparare. Tu non devi muoverti dalla porta. Entriamo, tu chiudi e ti metti a sorvegliare la gente. Chiunque si avvicini tu gli spari. Il Mullah ruggì il takbīr solcando la navata, alle sue spalle un paio di colpi colpirono i santi che fluttuavano sulle volte. Allah akbar min kulli shay’. La lama insanguinata indicava l’altare. I chierichetti cercarono di indirizzare l’anziano prete verso le scale della sagrestia, ma lui si allontanò con un gesto del braccio e invitò i fedeli a non muoversi. Qualcuno non ascoltò. Si mossero verso l’ingresso, abortendo subito lo scatto alla vista dell’uomo che sorvegliava la porta. Ma si mossero, il RAK aveva ancora tre quarti di caricatore di sprecare. Erano a una decina di metri dalla porta, quasi del tutto fermi, come indecisi sulla possibilità effettiva di tornare indietro e rimettersi seduti, ma senza alcun impedimento a farlo. Aduan sparò meglio di come non facesse con Xbox. Un uomo e una donna finirono a terra, un’altra scivolò nello spazio tra le panche dopo una sventagliata troppo ampia. Un paio di colpi attraversarono il legno e le finirono nella schiena. La messa sarà lunga, oggi, avvertì l’uomo salito sull’altare. Io sono Il Mullah e questa chiesa, ora, è conquistata da Daesh!
La decapitazione della signora Laporte era già stata ripostata da migliaia di pagine e profili bot in tutto il mondo, quando avviarono la diretta dalla chiesa –hanno detto dopo i giornali. Impossibile crederci, per chiunque abbia visto le cose da vicino.
Dieci minuti servirono alla Gendarmerie per accerchiare la chiesa mentre i colleghi di Évreux e Rouen si lanciavano in autostrada in direzioni opposte. In poco più di mezz’ora, tracciarono una zona di esclusione totale in un raggio di tre chilometri dalla chiesa. Gli agenti cedettero il posto alla teste di cuoio della Brigade de recherche et d’intervention, altri uomini in tuta tattica scura e passamontagna, preparati per quell’unico ma determinante avvenimento. Le forze dell’ordine prefigurarono un assedio rapidissimo mentre si accertavano sul numero degli ostaggi. Alle dieci e tredici, una mano agitò un fazzoletto bianco attraverso il portone. Ero fuori casa quando successe, riuscii a salire sul tetto del palazzo di Flora, da dove riuscivo a vedere la chiesa. Dagli altoparlanti dei blindati strillavano alla gente di non scendere in strada e non affacciarsi alle finestre. La donna venne invitata a uscire lentamente e identificarsi. Era una tizia peruviana, liberata per portare un messaggio alle forze speciali: pizza per gli ostaggi e cibo halāl per loro. Pare abbiano anche indicato un ristorante a Rouen in cui ordinarlo, qualcuno in paese sostiene di aver trovato il bigliettino. Nei paesi di provincia la gente è capace di sostenere qualsiasi idiozia. Non è chiaro se l’ordinazione sia stata mai stata fatta.
Scorsi delle sagome percorrere il sagrato, i due terroristi dovevano essere acquattati dietro di loro, ma presto la scena si spostò, i blindati fagocitarono la visuale e non vidi più niente. Un paio di colpi, due boati più grandi e profondi, un poco più forti delle bombe carta che fanno esplodere allo stadio. Poi, uno scroscio, più scariche, accavallate e mescolate insieme. Ho letto su Google che le forze speciali francesi usano fucili tipo HKG36, oppure dei più vecchi FAMAS, o della roba belga, tutti dello stesso calibro con caricatori da venti o trenta colpi. Non spararono per più di due minuti, senza che i suoni si spostassero di molto.
Qualche giorno dopo cancellammo Rouvray dai cartelli di confine con le bombolette. Nere. Finché l’amministrazione non troverà il tempo di pulire i cartelli di ingresso e uscita o metterne di nuovi, per tutti sarà Saint-Ètienne-du-Jihād.
L’organo di propaganda della Provincia del South Waziristan di Daesh ha rivelato di aver addestrato i combattenti nel Khyber e nel South Sudan per vibrare un fendente al cuore della cristianità. In paese, abbiamo tutti finto di crederci. I telegiornali non l’hanno nemmeno messo in dubbio.
Di madame Laporte, la cornacchia, invece, non hanno quasi parlato. La sua testa non fu notata fino alle ventitré – furono altri a postare il video, quando i due erano già morti, nel pomeriggio. Quasi mi sono sentito dispiaciuto, per tutti i dispetti che le avevo fatto.
Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?