Testo: Federico Zagni
Copertina: Frustrazione di carattere rabbioso – Marta Di Giovanni
#1
T come traffico.
Traffico che tintinna con sferragliare violento, clacson che bacchettano ritmici sui timpani, mentre Laura si sporge alla maniglia da dentro alla BMW, gli apre lo sportello. Ancora non ha imparato qual è il pulsante per lo sblocco, né le interessa.
La puzza di smog gli irrita la gola molto di più, adesso che sta per lasciarla. La recente gentrificazione del quartiere, unita alla disponibilità economica che il suo lavoro provvede, permette loro di vivere in una zona tranquilla, e costosa: ma a quest’ora basta fare due svolte per trovarsi imbullonati in una cotta di lamiera e stridìo. Alessio trascina la portiera di malavoglia, e tutto il mondo fuori si offusca in un acquario smerigliato. Di malavoglia, sì: è pur sempre l’ultima aria vera che respira, se aria si può definire quella miscela di scarichi e polveri.
Mentre vanno verso l’aeroporto Alessio continua a vedere le immagini plastificate di quel volto anziano e assente. Appeso a un semaforo; sul muro di un palazzo; contro a un palo della luce: il quartiere è costellato di manifestini stampati a colori, e man mano che si allontanano, le foto si diradano, in una ragnatela la cui rastremazione corrisponde alla probabilità topologica di ritrovare la vecchia signora.
A come Anita.
Laura guida nervosa, a scatti. Ora che nell’abitacolo si è addensato a gommapiuma quel silenzio, si percepisce anche il fruscio tangibile dell’insofferenza di lei; i piccoli sbuffi, i movimenti brevi e veloci che urtano il cruscotto. Laura lo odia in silenzio, ormai. O almeno odia quel suo lavoro, che è pressoché la stessa cosa. Non lo riconosce come martire, neanche fosse lei quella che deve passare settimane in una vergine di ferro. Frena bruscamente a un passaggio pedonale, e sveglia il bambino dietro di loro, che inizia a piangere.
– Quando hai detto che torni, stavolta?
Lui rimane un attimo sospeso, distratto dalle volute di profumo che le si spandono dal collo. Non glielo ha mai sentito addosso. L’ipotesi che lo abbia messo proprio per lui non collima con il suo tono sostenuto; e l’’osserva, come fosse la prima volta. Ha qualche segno ai lati della bocca, degli occhi, ma è ancora una bella donna. Mani troppo magre forse, pensa, osservandole le nocche sbiancare sul volante.
– Che profumo è? – risponde poi Alessio.
Lei lo osserva senza capire, mentre Mattia continua a piagnucolare sul seggiolino, ignorato. Solo un altro ostacolo alla loro comunicazione.
– Che profumo, cosa?
– Il profumo che hai addosso.
– Ma sei scemo? Me l’hai regalato tu due Natali fa.
Lui annuisce, anche se non convinto. Ricorda in effetti di averle regalato un profumo, qualche compleanno fa, forse proprio Natale. Ma non importa, anche fosse per le narici di un altro e non per le sue, sarebbe giusto così. Gli basta la certezza che Mattia lì dietro sia suo figlio, e quella non gliela può togliere nessuno. Nonostante i suoi otto mesi, già si intravede il suo mento con la fossetta, e l’attaccatura a spirale sulla volta della nuca.
Laura non dà la precedenza ad un ciclista, che bestemmia. Lei impreca di rimando, poi si volge verso di lui, destinandogli anche la razione di rabbia sottratta alla strada.
– Oh, ma quando torni, quindi?
– Dovrebbero essere quarantacinque giorni. Anche se…
Si interrompe. Sono già parecchio lontani dal quartiere, eppure… un altro manifesto di Anita.
“Alta un metro e sessantacinque… affetta da demenza… indossa un cappotto rosso…”
Trova indelicato l’accenno alla malattia, con quel nome così offensivo. È così che si riassume una vita? Poi riesce a finire la frase.
– Direi che saranno cinquanta giorni. Compreso il viaggio. Per metà dicembre sono di nuovo a casa.
– Quanto sotto?
– Ottanta.
Le labbra le si schiacciano, in una smorfia che trattiene parole in piena. Aspetta sempre fino all’ultimo a chiedere dettagli, per ridurre l’ansia o per disinteresse. Lui di rimando centellina le risposte, per ripicca o per fastidio. La vede, che rinuncia a domandare altro, sa che ormai quando deve partire è teso. Anzi, nemmeno teso, se non nel vero senso della parola. Si sente proteso. Proiettato verso il blu. Non ha ancora capito se poi gli piaccia davvero, nonostante gli anni, ma intanto rimane un anelito costante sepolto in pancia, quando ne è fuori.
Con una brusca frenata, Laura parcheggia nel kiss and drive. Mattia ha smesso di piangere, e singhiozza sommessamente, incuriosito e forse, Alessio spera, anche un po’ desolato per questo abbandono, già vissuto un paio di volte, pur senza ricordarselo. Si sporge dietro per un buffetto, un saluto, poi gira intorno all’auto per prendere i borsoni. Appena si volta, si trova la moglie a fianco. Fermi, uno di fronte all’altro, con il portellone ancora aperto, Laura lo bacia velocemente, ma mentre lui fa per allontanarsi, preso ormai nel vortice della fuga, e quasi già in odore di ruggine e mare, lo ferma strizzandogli forte un braccio, in un gesto che è mezzo rancore e mezzo amore.
– Fai a modo, laggiù. Non farmi stare in pensiero. Siete ancora in… Scozia?
– Norvegia. Al largo della Norvegia.
A parte gli aeroporti e una porzione di mare, l’unica cosa che cambia è l’abbigliamento da mettere in valigia.
– Ci sentiamo appena sono arrivato, – dice lui mentre si allontana, subito assorbito dal suo flusso di pensieri.
– Che, avrete rete dentro? Riusciamo a sentirci, Ale? – sembra quasi lo implori.
– Eh, vediamo. Dipende da com’è il tugurio. Non è uno di quelli degli americani, questo… credo sia un impianto modulare.
Dove cazzo sta andando il suo matrimonio, che appena li lascia smettono di mancargli. Che è un po’ come dire che non gli mancano mai, eppure sa che non è così. È soltanto che il mondo astrale che lo aspetta è un luogo così diverso, trascendentale e al tempo stesso del tutto familiare, che non riesce più a ricollegare le due vite, se non con un ombelicale ancora più sottile di quello che lo tiene vivo mentre è a pressione negativa.
Ma un secondo prima di varcare le porte trasparenti si arresta, e si rivolge ancora alla moglie, che è ferma lì a guardarlo partire. Una moderna Penelope, stoica e traballante sulle sue Jimmy Choo. Alessio non può che pensare che si faccia scopare da qualcun altro, mentre lui è via. Poi si sente in colpa. Probabilmente no, ma se non lo fa ora, giustamente lo farà presto.
Alessio le indica una delle due porte scorrevoli, su cui ballonzola un A4 incollato su tre angoli. Indica ancora la faccia di Anita, la vecchia signora smarrita ormai da due settimane e che è diventata suo malgrado la persona più famosa in città.
– L’hanno poi ritrovata?
Laura assottiglia gli occhi, inarcando un labbro mentre ritrae il capo.
– Ma di cosa parli?
Alessio batte ancora sul foglio. Scandisce:
– “Si è smarrita il giorno ventuno… se la vedete chiamate immediatamente…”, Laura, ma tutta la città la sta cercando da due settimane. Questa cosa mi manda ai pazzi, come è possibile che una sparisca così, mentre ci si volta per legare la bicicletta, un attimo e la vecchia con l’Alzheimer è scomparsa?
Laura si gira senza rispondergli, sale in macchina e se ne va.
Alessio sospira e passa in mezzo alle porte automatiche. Gli mancherà anche il suo nuovo profumo.
Quattordici ore di maglietta incollata al torace, torpore e risvegli su seggiole di plastica, annunci di fredde voci metalliche, giochini sullo smartphone, il martellare delle pale dell’elicottero, la sferzata dell’aria fredda in alto mare e finalmente, i piedi sulla lamiera antiscivolo della strana isola di metallo che gli farà da albergo, nazione e continente.
Cerca di non guardare troppo il mare. Da dove si trovano adesso riescono a scorgere appena i profili frastagliati delle cordigliere norvegesi. Ma il mondo che lo aspetta è quello subacqueo, e respirare troppo l’aria gelida del Mare del Nord, o fissare la purezza delle cime di fronte a lui rischia di provocargli un’inutile vertigine. Nel suo turno di riposo sulla nave una volta ha assistito anche ad un’aurora boreale; ma quando è dentro all’impianto non guarda mai dall’oblò, è piccolo e sporco, e fissarsi sul fuori a cosa servirebbe?
In quel punto riescono ad avere connessione. Alessio fa un salto in cabina di controllo per chiamare a casa. Giusto venti secondi, per dire “Tranquilla amo’, sono arrivato e domani vado sotto.”
Con le ultime energie si presenta al supervisore tecnico, al caposquadra; si fa assegnare le consegne, saluta i cinque compagni di prigionia, con cui scambia solo poche parole senza significato; poi si precipita sotto coperta, cercando di rosicchiare quelle ultime ore di riposo rollante prima di farsi inumare nel metallo.
In quei cinque anni di immersioni non ha intessuto nessun rapporto coi colleghi, quasi tutti mercenari, anche se si tratta di andarci a letto insieme, in pratica. Alcuni li incontra spesso, altri li vede e non li vedrà mai più. Il fatto che la sua vita dipenda da loro è un aspetto marginale, esula dai rapporti umani per rientrare comunque in quelli professionali. Dei marinai gli manca il senso dell’onore, dei militari quello del dovere. E quando il lavoro è così rischioso, fa parte del gioco raccomandare ad altri la propria anima, ed essere pronti a ripescare quella altrui; ma in sette anni di immersioni lui non ha mai salvato la vita a nessuno, e nessuno a lui; non si è dovuto tatuare nomi in segno di riconoscenza, e ne è felice.
La nave oscilla appena, aiutandolo a prendere sonno, anche se non ce n’è alcun bisogno. Sprofonda in un istante nella caligine, è così stanco che non riesce nemmeno a sognare.
#2
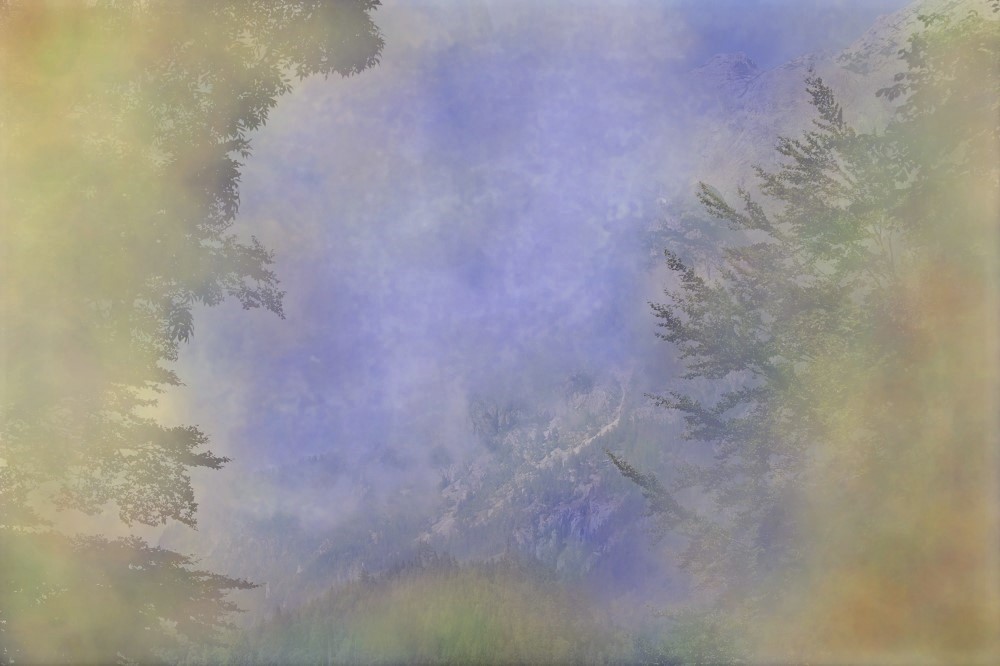
La mattina dopo è il primo ad entrare in saturazione. Il modulare che li ospiterà è montato direttamente sul deck della nave. Ad Alessio pare un po’ più grande dei soliti, magari stavolta staranno un po’ più comodi lì dentro.
Sfila le scarpe, si abbassa e scivola nel boccaporto di metallo. Da dentro l’oblò osserva i compagni piegati seguirlo.
Egor, il russo che sarà suo compagno di lavoro per i successivi ventotto turni, prima di entrare lo guarda e ride.
– C’è buona aria, dentro? Fresca?
È la sua prima saturazione, e cerca di frenare l’ansia chiacchierando più che può, ma non sa nemmeno bene l’italiano, e l’unica cosa che si può fare lì dentro è leggere, o parlare. Ed Egor non si è portato nemmeno un libro; lo aspetta un mese difficile. Ci vuole qualche giro di giostra per capire che, lì dentro, o leggi o scoppi. Alessio non aveva mai letto nulla prima di iniziare con le saturazioni: ora prima di partire fa un salto in libreria e sceglie senza pensare, guidato solo dalle immagini di copertina, dai visi degli scrittori barbuti in bianco e nero dietro alla copertina spessa. Per questo gli pare che, anno dopo anno, la sua mente si sia come allargata, e che ora possa contenere tanta, forse troppa roba; anche cose di cui avrebbe fatto volentieri a meno.
Dopo il ragazzino entrano Francesco e Mauro, due italiani con un po’ di esperienza, che se ne stanno in silenzio e iniziano subito a disporre la roba nelle cuccette. Ci ha già lavorato altre volte, sono due colleghi a posto, e sono “fratelli” di immersione. Chiama così quei compagni che instaurano rapporti così stretti da accettare in pratica solo lavori in coppia. Sono affiatati, lavorano alla perfezione e le grosse aziende ci guadagnano, evitando incomprensioni e battibecchi.
Infine ecco Klaus, un tedesco che non ha mai visto, e per ultimo un francese di cui non ha nemmeno capito il nome.
Alessio si riaffaccia. È il veterano in ognuna delle saturazioni che fa ormai. Il vecchio di bordo; è raro che si resista così a lungo. L’ultima cosa vede è la faccia di Kùmar che lo saluta con ammirazione. “Stai seif ma friend, oll thi best” continua a ripetere con la sua buffa inflessione indiana, mentre a fianco a lui Pravgan controlla il portello dall’esterno, prima di chiuderlo. Giungono le mani da dietro al vetro, da cui pende il barometro rotondo. Li venerano, come farebbero se fossero sommergibilisti di marina, o astronauti mandati ad esplorare il lato nascosto di un satellite. O anche, mucche: mucche mandate ad arare i fondali, per ottocento dollari al giorno.
Così si trovano chiusi dentro, in sei sconosciuti, pronti ad aspettare la saturazione. Alessio si sdraia in cuccetta, prevedendo l’ilarità che l’aumento dell’elio nella cabina genera in tutti i novellini. Sente il sibilo, percepisce la pressione che inizia a salire lentamente, avverte le voci di tutti diventare pian piano “a Paperino”. Le risate, inquiete e forzate, di chi sente qualcosa che cambia nel proprio corpo, anche se ormai c’è abituato: le articolazioni che scricchiolano in maniera sinistra, i timpani schiacciati e distesi da sbadigli posticci, vampate e gelo che oscillano di continuo. Una discesa immaginaria, dieci metri un’atmosfera, rimanendo ancorati alla nave, e ogni bar che si aggiunge sul barometro significa un gradino, un nuovo gradino che allontana dal Reale: per arrivare a meno ottanta impiegheranno ore, e Alessio si addormenta di nuovo.
Il primo giorno di lavoro il loro turno è il secondo. Mentre scendono, con il modulo di discesa che dondola proprio come una vera campana in una domenica a festa, ripete meccanicamente a Egor di stare tranquillo. A dire il vero dei due quello che si dovrebbe preoccupare di più è lui; se dovesse succedergli qualcosa un pivello come il russo non potrebbe aiutarlo in alcun modo. Fanno la checklist a voce alta, con le loro voci poco comprensibili. Tra i loro differenti accenti e il timbro da elio, non c’è modo di capirsi bene se non indicando: e dopo che ha completato la vestizione, nemmeno così. Infine Alessio scende dalla botola, ed eccolo lì: sua maestà il Blu. Lo chiama il Blu, lo immagina blu, come fanno i sommozzatori, ma più che blu è un nero che vira appena al ciano. Non riesce a vedere nulla oltre il metro, anche perché non appena la luce del faro si perde all’orizzonte non rimane nulla da vedere. C’è un po’ di corrente e il fondo è polveroso. Peccato perché normalmente i fondali norvegesi sono tra i più limpidi. Dopo la botta di adrenalina legata al freddo, e al trovarsi su un terreno marziano, Alessio prova a rallentare il battito del cuore. Percepisce il suo respiro, solamente quello. In entrata. E in uscita. Le bolle che sputa fuori, che risalgono verso il mondo che ha lasciato. Tra qualche minuto esploderanno in superficie, dopo essersi dilatate e frantumate in mille gocce gassose. Poi inizia a rilassarsi. Devono collegare con alcune flange due portanti gassose, e Alessio si fa mandare giù la prima coi palloni. La fa volteggiare come fosse un Ercole, da dove si trova non si vede nemmeno il cavo che la sostiene. Gli arriva quella placida sensazione di potere, di lenta e rara efficacia, che sulla terraferma manca: lavora maneggiando oggetti e strumenti che pesano decine di chili, e quando viene l’ora di tornare nella campana è perfino dispiaciuto. Risale, e si fa aiutare a sfilare il casco. Non ha più forza nelle braccia, né fiato. Per essere la prima giornata, forse ha esagerato.
Passa le quattro ore successive ad assistere il compagno, a controllare che non faccia cazzate, ammazzandosi. Egor è molto giovane, è robusto, a volte si fa prendere dalla fretta e Alessio deve richiamarlo; ma si accorge di provare una punta di invidia constatando che quella forza, quella capacità di lavorare anche per quattro ore di fila, ormai lui la sta perdendo. Deve compensare con l’esperienza, ormai quelli che hanno così tante ore a pressione negativa si contano sulle dita di una mano, in Italia. E Laura vorrebbe che mollasse tutto, adesso? O che almeno finisse a fare il supervisore tecnico. E per cosa, allora? A cosa servirebbe? A cosa sarebbe servito tutto questo?
Mentre scruta il fondale dal fondo aperto della campana, gli sembra di intravedere un guizzo. Una terza figura, giù con loro. Il cuore gli perde un battito, poi capisce che è solo un baluginio del frontale di Egor, che sta tornando verso la campana.
Insieme, risalgono lentamente nella cupola di fruscio e rimbombo metallico. Senza dire una parola. Lo shift è stato pesante, nessuno dei due parla; Egor è ancora come inebetito dalla stanchezza. Lui invece, beh. Pensava che quella discesa gli avrebbe cavato via il fastidio, l’ansia che lo afferra da giorni. Forse da mesi. Invece sente che gli manca ancora qualcosa.
Alla fine sono su, si strizzano per i boccaporti e si ritrovano di nuovo nel loro minuscolo appartamento. Alessio si stende sul letto senza una parola, e di nuovo percepisce quella inquieta vivacità che lo coglie. Quando i nonni lo chiamavano Argentovivo, mai avrebbero pensato che potesse resistere a stare per un mese in venti metri quadri calpestabili. Allora elenca, come gli ha insegnato suo padre. La tecnica dell’alfabeto.
B come bullone. È pieno di bulloni, lì dentro. Come essere nella pancia della balena di metallo. C come casco. Il casco giallo, prezioso come l’oro. L come libro. Se ne è portati venti, ormai lì sotto legge soltanto. Impossibile fare affidamento sulla rete, che a volte c’è a volte non c’è, e i film finiscono subito. Ne afferra uno, prova a iniziarlo. Ma le parole gli si fanno pesanti in mano, il libro gli cade sulla faccia, nemmeno se ne accorge.
E c’è lui, lui nell’appartamento di casa sua. Laura esce dalla porta, lui la chiama, lei non si volta, scendono le scale uno dietro l’altro e non riesce mai a raggiungerla; intanto le si sgola dietro, piani e piani, ma lei nulla, arriva al piano terra, la porta si sta chiudendo, si tuffa per fermarla, ma il metallo gli si chiude sulle dita; è massiccio, come le porte delle chiese, come il coperchio di un pianoforte, il coperchio di una bara. Le dita si spezzano, non possono fare altro, e c’è sangue, tanto sangue. E subito i moncherini delle dita sono spariti, lui si fissa le mani insanguinate e sono diventate due palle di carne viva, all’altezza del polso: con quelle palle non riesce ad afferrare la maniglia, è chiuso dentro. Oltre alla porta a vetri Laura si gira verso di lui, finalmente vedendolo: ma no, non lo vede, non lo osserva, lo sguardo di lei lo attraversa vacuo, fisso e vuoto come quello di un cadavere che galleggia da giorni, si volta e si allontana ancora, mentre lui chiama, chiama il suo nome. Laura. Laura. L come Laura. L come Laura. E mentre sparisce nel torbido gli sembra sempre più anziana, più bassa, i capelli le si fanno radi e finissimi, le si staccano a ciocche, e gli ricorda qualcuno, una donna, anziana, al pianoforte per giorni interi, con un cappotto, un cappotto rosso.
Si sveglia completamente gelato, nella penombra delle luci di cortesia dell’impianto, e per qualche interminabile secondo non riesce a muoversi. Dio fa che non sia una paralisi notturna, Dio no. Dall’oblò filtra un altro po’ di luce. C’è freddo adesso, per colpa della miscela di heliox la temperatura in quelle camere è sempre un’altalena Sente umido, sente giungere il panico. Poi per fortuna, il suo corpo inizia a rispondere, schivando quel limbo in cui qualcuno di mostruoso gli si siede sul petto tenendogli i polsi con le mani. Gli è capitato una volta soltanto, e ancora lo ricorda con orrore. Si stiracchia, giusto per dimostrare a sé stesso che può muoversi, che è davvero cosciente e padrone. Ma ora può solo provare a riaddormentarsi, non vuole svegliare tutti i colleghi, e poi ormai che si è dentro l’unica cosa che si può fare è resistere. Per una decompressione d’emergenza ci vogliono comunque ore, e non te la fanno certo per un attacco di panico. Perché è questo che ha, no? Un semplice attacco di panico?
#3

Il giorno dopo hanno da saldare. Per primo come sempre esce lui. Le particelle che fluttuano illuminate dai fari gli ricordano una neve fine che cade sulla luna. Anche se sulla luna non nevica. O nevica? Giurerebbe di ricordare un paio di foto di un monte lunare imbiancato. Passa ore come in uno stato di stasi mentale, un anodino nirvana cerebrale di cui non si rende nemmeno conto. In quello che gli pare un quarto d’ora ha finito di saldare, e guardando l’orologio si accorge che ha pericolosamente sforato la sua quota oraria. Come da una nebbia sonora, sente emergere la voce di Egor che lo chiama, concitato.
– Tuo tempo finito, Ale, torna dentro.
– E ‘ua arrivo, stai calmo.
Nella campana, mentre si fa aiutare a togliere il casco vede dei piccoli lampi colorati ai margini del suo campo visivo. Non gli è mai successo, ma l’unica cosa che riesce a pensare è che vorrebbe tornare di nuovo là sotto. Farsi schiacciare dal nero sopra di lui, farsi assorbire, come un’escrescenza morbosa del mare, diventare mare. M come mare. Diventare nulla. N come nulla.
– Ma che successo, Ale? Non stai bene?
Alessio lo guarda, ostenta tranquillità.
– Ma che, faccio sto lavoro da vent’anni. Eri nato tu, vent’anni fa?
– Capito, ma non rispondevi. Io chiamavo, tu silenzio.
Le loro voci gracchianti sono incomprensibili. Nel nero delle mute sembrano due corvi sgraziati che bisticciano per un verme. Alessio stesso non capisce più esattamente cosa sta dicendo, e gli indica il pozzo sotto pieno di acqua. È il turno di Egor, che scenda, che esca, che lo lasci in pace. Gli fa segno di calarsi. Finisce di aiutarlo, lo sente un po’ agitato quando gli apre la manetta, e gli fa segno con il pollice.
– Per ogni cosa, io sono qui.
Lo guarda scivolare giù, nella gabbia e poi sul fondale. E si abbandona sul pavimento zigrinato della campana, in mezzo ai rotoli di cavi.
Quando aveva iniziato ad avere gli attacchi, da bambino. Un respiro sempre più agitato, un cerchio nero che gli si chiudeva sulle palpebre, come avere occhi chiusi, ma forati.
Suo padre lo abbracciava, lo teneva stretto, fino quasi a bloccargli il fiato. Lo schiacciava a mille atmosfere, lo includeva in sé.
– Tieni duro, Ale, passa tutto. Passa tutto. Contiamo insieme, ti va?
– “A” come… come cosa, Ale?
E lo obbligava a riaprire gli occhi, dal nero. Lo costringeva a tornare in superficie, a tornare al mondo. A osservare.
– “A” come… A come Aceto, – indicando la bottiglietta nera sul tavolo in cucina.
Suo padre è lì con lui, gli accarezza la testa.
Oggi la rete funziona. Scrive a Laura, non la chiama mai perché a quella quota l’elio che lo chef prepara è così concentrato che la sua voce non è comprensibile per lei che non è avvezza.
*Ciao
*Ciao, come stai? sono passati quattro giorni senza sentirci
*Tutto bene, oggi la rete piglia, prima non prendeva mai
*Com’è il mare?
*Fermo, ma freddo. Molto freddo.
*Hai abbastanza coperte lì?
*Ma sì, non ti preoccupare. A casa tutto bene? Mattia?
Laura ci mette un po’ a rispondere. Scrive, cancella, scrive e riscrive. Alla fine appare il messaggio.
*Sta bene, mangia e dorme.
Poi , qualche secondo più tardi.
*Ci manchi
Anche voi mi mancate, scrive lui.
*Ma,* aggiunge, per poi rimanere con il messaggio a metà, indeciso.
*Ma l’hanno poi trovata la signora?
Laura risponde solo con un laconico *No
I giorni sono tutti uguali. Hanno un calendario coperto di croci, a ogni croce i colleghi hanno sempre meno voglia di parlare, e alzarsi dal letto diventa più faticoso. Nonostante il menu ben calibrato che pescano ogni sei ore dalla camera di equilibrio, stanno tutti smagrendo. Chi ha la barba lunga, chi le occhiaie fonde.
Al sedicesimo giorno Alessio discute con Fabiano per un nonnulla. Ha lasciato in bagno il libro che sta leggendo, chiede al compagno di aprirgli. Fabiano rifiuta, dice che lo prenderà dopo. Quando, dopo trentacinque minuti finalmente apre la botola del tronchetto di mezzo, Alessio lo accusa di avergli perso il segno.
– Era chiuso, – dice Fabiano.
– Era aperto a faccia giù.
– Mi sa che dici stronzate, ma fa lo stesso. Cercati sto cazzo di segno, – dice, e gli fa svolazzare il libro sul letto, con stizza.
Alessio lo recupera, squadernato gli sembra un gabbiano ferito, e lascia perdere: sa bene che non è il caso di attaccarsi per queste inezie. Torna a sdraiarsi sul letto, ma non riesce più a leggere. Continua a pensare a che fine può aver fatto la vecchia. Caduta in un pozzetto, e morta senza che nessuno dei parenti la possa trovare? Eppure hanno cercato dappertutto, in un raggio di chilometri. Rapita dai rom che stanno dietro alla stazione? Ma per farci cosa? Se la raffigura intenta a rammendare in una delle loro roulotte, tutto sommato felice. Ormai non ricorda più nulla della sua vecchia famiglia e questi nuovi colorati carrozzai le danno tutto quello di cui ha bisogno: cercavano solo una nonna.
Tira fuori il telefono, e si mette a cercare su internet. La rete va e viene, ma riesce a caricare una pagina.
“Ancora nessuna notizia, le ricerche proseguono ora solo tramite i volontari. Sono stati dragati i laghetti di San Vitale, ma nemmeno con i cani è stato possibile risalire a una traccia dell’anziana…”
Forse si è solo stancata di stare in quella famiglia, ha preso i risparmi di una vita e magari ora è su qualche spiaggia. O magari i parenti stessi, l’hanno fatta sparire perché sapeva troppo e ora stanno depistando le indagini.
Poi si addormenta e sogna ancora. È sott’acqua, o in una foresta aliena. Ci sono alghe veleggianti, galleggia in un mare di elio, che pian piano si trasforma in una viscosa melassa trasparente. Fa sempre più fatica a muoversi. Ha il saldatore in mano, ma diventa sempre più pesante e alla fine lo lascia cadere. Si volta. Si guarda intorno. C’è di nuovo la neve fine che spazzola la radura. Fino a dove riesce a illuminare la sua torcia. Meduse bianche fluttuanti. Ma non sono altro che sempiterni sacchetti di plastica. Ci sono i tubi. Che spariscono enormi all’orizzonte subacqueo. E di fianco a un tubo. C’è un palo. Con uno strano volantino. Alessio si scuote. Si sposta. Lentamente si avvicina. Metro dopo metro riesce ad arrivare al palo. Non è un palo; è un albero. E sopra c’è il solito volantino.
“Si è perduta… risponde al nome… A come…”
Ma sul volantino non ‘è il nome di Anita. C’è il nome di sua madre, Adele.
Lo sveglia un grido concitato di Egor, che si è messo a biascicare incomprensibile. Capisce solo il suo nome, ripetuto. E non sono più nell’impianto di saturazione.
– Fabio, Fabio, čto proischodit? Ty menja slyšiš’? slyšiš’ menja?
Apre gli occhi, ed è sott’acqua. Non ricorda nemmeno di essere sceso per il turno, eppure evidentemente lo ha fatto. Il saldatore penzola quattro metri sotto di lui, e lui è artigliato con l’avambraccio ad un montante, con l’ombelicale tutto attorcigliato al collo. Anche quando è nato aveva il cordone attorno al collo, no? O forse non era lui…
– Ja pridu, ty ne uchodi. Idu uže!
Egor sta continuando a urlare dalla campana. Impossibile capirlo. Ma altre voci si sentono negli auricolari del casco. Sono gli altri colleghi, dalla camera di saturazione. Alessio sospira, deve aver fatto un grosso casino, perdendo i sensi così.
Mentre si allontana, risalendo verso la campana, da sotto alla gabbia Anita gli rivolge un cenno di saluto, prima di scomparire nel blu.
– Ma che cazzo succede, Ale? – grida Fabiano dall’interfono, mentre risalgono in campana.
Egor è scosso, abbassa la testa. Non ci sta a fare la sua prima saturazione con un compagno che non è lucido, che non risponde e non rientra quando è il suo turno. Si era già rimesso il suo casco, da solo, per venire a soccorrerlo, e Alessio prova un istintivo moto di affetto per quel russo allampanato e goffo, e vorrebbe abbracciarlo, stringerlo anche lui.
– Ma niente, Egor si è fatto prendere dal panico, non mi funzionava l’audio e non sentivo…
Silenzio di Fabiano, ma interviene Mauro.
– E com’è che sei rimasto sotto venti minuti di più? Lo sai che da protocollo…
– Lo so, secondo te non lo so? Dovevo finire un giunto, che facevo lo lasciavo a metà?
Sente i compagni che in parte si tranquillizzano, gli credono, vogliono credergli. Quando arrivano su, dopo la risalita della campana, gli danno pacche sulle spalle.
– Ci hai fatto prendere un bello spavento, coglione! E rispondi a ‘sto cazzo di interfono.
Il tedesco si sta preparando per il suo turno, la loro risalita a metà lo obbliga a scendere prima. È seccato e non pare interessato alle sue motivazioni, lo fissa dal basso verso l’alto, seduto, con i gomiti sulle ginocchia.
Poi Fabiano e Egor si spostano nella loro sezione, da soli. Gli stringe una spalla.
– Tutt’appost, Egor?
Lui annuisce, ma non è convinto come gli altri. Lui gli ha visto gli occhi, quando è riemerso dalla botola nella campana.
I due prendono la cena dal passavivande del tronchetto centrale, si mettono sulle cuccette ognuno per conto suo, e per un po’ si sente solo il rumore delle guance che risucchiano, delle mascelle che schiacciano. Alessio affetta una mela, ne osserva il gambetto. Il picciolo. Non è altro che un cordone ombelicale, in fondo. Nasciamo con un ombelico perché un tempo ci serviva un’àncora. Ora non lo abbiamo più, ma senza, i marosi ci squassano l’anima.
Alessio riflette, forse c’è qualcosa nel gas. Il suo cervello non funziona più bene, se ne va per conto suo. La neve lunare? Il picciolo ombelicale? Forse lo chef ha sbagliato la miscela, ha tagliato male l’heliox e li sta intossicando, per questo ha le allucinazioni. Perché solo lui però?
Finisce il pasto, un risotto con dei carciofi che sembrano gelatina impastata con paglia delle sedie. Si sdraia sul suo letto, fissa il soffitto curvo su cui ha appiccicato la prima foto di suo figlio in sala parto, e si abbandona ai ricordi. Da quando è arrivato quel minuscolo essere, gli pare che tutto abbia iniziato a girare più veloce. Forse ha ragione Laura, perché non piantarla con quel mestiere? Ormai non riesce più a stare al passo, e potrebbe trovare qualcosa anche a Genova, sforzandosi un po’. O magari, potrebbero trasferirsi. Isole, estero. Fare l’istruttore, con la sua esperienza troverebbe facilmente qualche impiego. Certo dovrebbero accontentarsi. Dovrebbe vendere la casa. Certo sarebbero molti cambiamenti. Ma Laura glielo chiede ormai ogni volta che torna. E anzi, non gli chiede davvero quello. Gli chiede di essere lì, almeno un po’. Di non immergersi nuovamente mentre è lì con loro.
Ma Alessio sente quella zavorra che lo trascina a fondo. E da quando è padre ha paura di lasciarsi andare. Di farsi prendere dal Blu.
#4

Il giorno dopo si sente riposato, in forze. Ormai mancano tre giorni e inizieranno la decompressione, per tornare a casa.
Quando si sposta nel disimpegno per prepararsi, vede Egor che non si alza dal letto.
– Che fai, alzati. Tocca a noi, – dice indicando con la mano il portello verso la camera di equilibrio con la campana.
Ma Egor fa cenno di no, e si gira su un fianco.
È Maurice a chiamarlo, dall’altra sezione.
– Vengo io. Ho fatto a cambio.
Alessio non commenta. Ci mancava solo andare giù con il francese.
Mentre scendono in campana, Maurice chiede di andare per primo. Ad Alessio non importa. Lo attrezza con perizia, preoccupato che sia lì principalmente per controllarlo. Non vuole rovinarsi la reputazione, ma deve ammettere che Maurice sembra concentrato solo sul lavoro da compiere.
E infine lo guarda tuffarsi e scendere, fino a che non distingue solo la punta gialla del casco e le luci.
Nel rimanere solo, ad ascoltare gli scossoni della campana, appesa alla nave, a senza poter vedere nulla, viene nuovamente preso dalla stanchezza. Ormai anche questa saturazione è finita, tra poco si torna a casa, si torna da suo figlio. Ricorda di nuovo il momento della nascita di Mattia, la sua prima emersione nel mondo, se così si può dire. Quello che aveva provato a tenerlo tra le braccia, la paura senza fine quando gli era sembrato che i medici si agitassero intorno alla moglie, il senso di colpa per averla persa di vista un attimo. Aveva avuto un emorragia interna, l’avevano ripresa in pochi minuti, ma la vista dei suoi occhi che si capovolgevano bianchi all’indietro mentre lui teneva quel fagotto sporco e urlante in una mano, non l’avrebbe mai dimenticata.
Poi, come in trance, prende l’equipaggiamento di standby, la maschera morbida. Dovrebbe servire solo per dare supporto, in caso di emergenza, ma non c’è nessuna emergenza; eppure per lui è come se. Lo indossa da solo, sistema tutti i velcri su spalle e braccia, tira le cinghie, apre la manetta, e scende anche lui nella botola.
Maurice è lontano, non guarda in alto, e lui bada a non puntare le torce nella direzione del compagno. Scende, scende, come una piuma scossa dal vento marino, atterra sul suolo del pianeta segreto. Cammina lentamente, volgendosi indietro per osservare le sue impronte polverose, che si dissolvono nella fanghiglia, verso la piattaforma di lavoro alle sue spalle. Ormai le luci di Maurice non sono più visibili da dove si trova lui, e quindi nemmeno lui può essere visto. Si volta, ed è nel nulla. Sforzandosi riesce a capire che è notte, nel mondo reale. A quella profondità non c’è davvero differenza, e le ore sono tutte uguali quando si sta nell’impianto di saturazione, ma lui ha l’esperienza per distinguere quel buio un pelo più buio che è la vera notte. Ad alcuni diver non piace lavorare ad alte profondità anche per quel motivo, invece per lui è più bello; si è così lontani dall’universo che nemmeno il sole può più guidarti. Si guarda intorno, e finalmente si sente una briciola. Una voce lo fa sussultare, ma è quella di Maurice, nelle cuffie: dice che sta per finire e tra poco tornerà su.
Alessio deve fare presto.
E all’improvviso, di fianco a lui, c’è la signora scomparsa.
– Anita, – dice Alessio, un nome che suona come un’interrogazione.
La signora annuisce con il suo cappotto fluttuante nelle onde.
– Che fine avevi fatto, Anita, – chiede.
Ma lei inizia ad allontanarsi.
– Aspetta, – la implora. – Non andartene.
L’anziana volge il capo.
– Ma io non sono tua madre.
Alessio non capisce. Di fianco all’anziana ora vede una strana impalcatura legnosa, coperta di edera marina, alghe, di muffa verdastra. Un piccolo lettino, da neonato. Sua madre Adele che rientra dall’ospedale senza alcun sorriso, suo padre che porta faticosamente su per le scale una carrozzina vuota. Che scuote la testa, anche se glielo aveva già detto la sera prima, che non ci sarebbe stato nessun fratellino, per adesso. La porta della stanza dei genitori che si chiude, sua madre che entra traballando, per non riemergere mai più come prima. Da quel giorno ogni suo traguardo, – il saggio di pianoforte, i primi risultati con le giovanili del Genoa – ogni risultato, era stato accolto da un moto fine di sole labbra; e ogni problema lei lo aveva liquidato scuotendo la testa, e con la stessa, identica, smorfia di circostanza. Successi, fallimenti, per lei era tutto uguale. Da quel giorno, il nulla era entrato dentro a sua madre, e non l’avrebbe mai più lasciata andare.
– Anche io ho perso un fratello, sai? E anche una mamma… – grida, senza più trattenere le lacrime, che sente scendere calde dietro al vetro della maschera.
L’anziana non c’è più. Alessio si volta, riesce a intravedere le lampade di Maurice, deve essere passato solo un minuto. Per un istante gli viene voglia di allontanarsi, sprofondare lontano dalle luci. Sdraiarsi a terra, Staccare l’ombelicale, lasciare che poco a poco i bagliori si spengano, lo lascino in pace. Ma poi gli ritorna in mente quel fagotto, che lo aspetta a casa. Gettato in acqua morirebbe in pochi secondi. Forse è ora di andare avanti, anche se quello che c’è di fronte lo spaventa più del nulla che ha qui al suo fianco.
Alessio si stacca dal suolo, inizia a sbattere le pinne e a volare verso l’alto, tenendo il cordone con le mani come guida, fino a che non vede apparire la luce fioca dei riflettori attorno alla gabbia. Scivola tra gli strati d’acqua gelida, percosso da brividi, fino ad emergere dalla pozza d’acqua del modulo di discesa. Si aggrappa e si tira fuori da solo, e si sdraia sul pavimento.
Non ce la faccio a fare il turno, Maurice, portami su, – dice, quando da quello stesso buco vede uscire il collega.
Mentre risalgono, lui lo osserva con sospetto. Forse l’ha visto uscire, di certo ha notato l’acqua che ancora lo bagna. Forse ha visto i suoi occhi, che paiono quelli di chi è nato ancora una volta.
Appena dentro la camera, Alessio prende il ricevitore verso la cabina di controllo.
– Devo iniziare la decompressione. Sì, adesso. Non ce la faccio più a continuare.
Poi afferra il telefono, digita un paio di messaggi.
*Sto tornando
E subito corregge.
*Sono tornato

